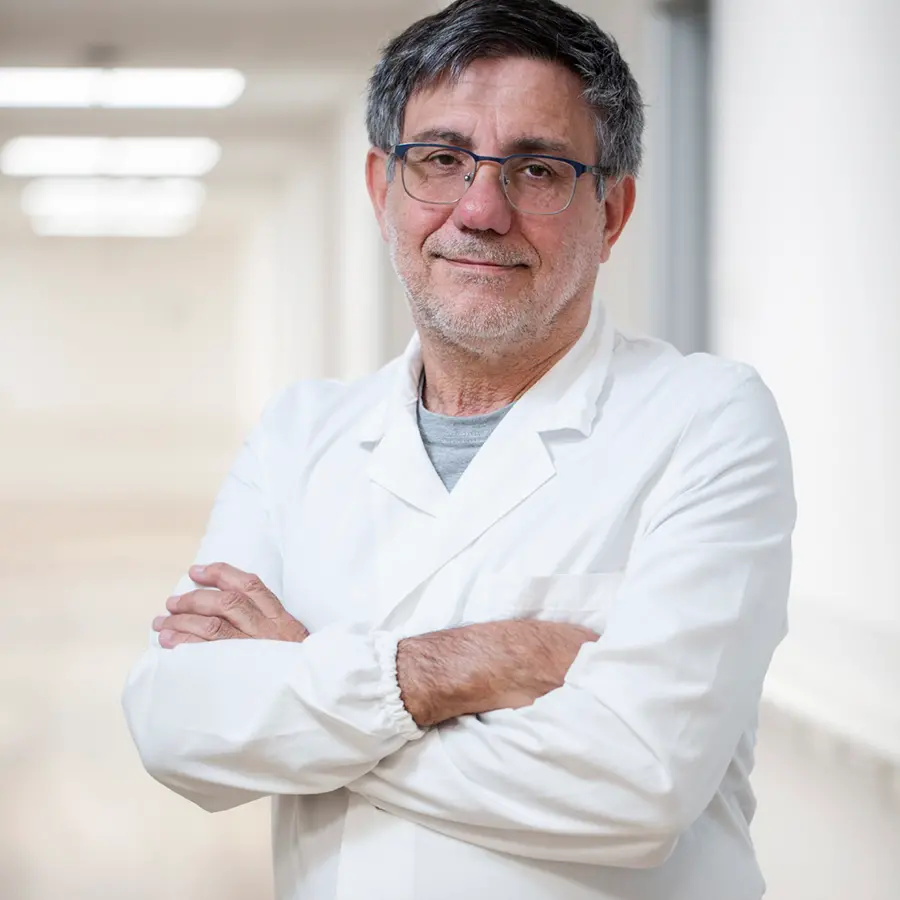PHOTO
Chiunque potrebbe avere un sangue raro, che è come un farmaco su misura per alcune persone. Chi ce l’ha potrebbe custodire nelle sue vene un dono prezioso per la vita di qualcun altro. E in Italia compie vent’anni una Banca del sangue raro, al Policlinico di Milano, che custodisce questo plasma preziosissimo. Da quando esiste, ha raccolto sacche di oltre 20mila donatori con caratteristiche diverse da quelle dei comuni gruppi A, B, 0 e Rh.
Sono messe a disposizione di chi ne ha bisogno, per trasfusioni o malattie, oppure per preparare terapie utili in gravidanze a rischio.
La leggenda dell’uomo dal braccio d’oro
Per capire di che si tratta, va raccontata la storia di James Harrison, divenuto leggenda come “l’uomo dal braccio d’oro”. La sua scomparsa, avvenuta a febbraio del 2025 nella quiete di una casa di riposo australiana, è stata ricordata da oltre due milioni di individui che si erano salvati, nel grembo della madre o appena nati, grazie al suo plasma.
Harrison prestò il suo famoso braccio alla medicina per la prima volta a 18 anni, scoprendo che il suo sangue aveva una particolarità: conteneva moltissimi anticorpi anti-D, rarissimi e fondamentali per prevenire la malattia emolitica del neonato. La patologia è causata dall’incompatibilità tra la gestante, con sangue Rh negativo, e il figlio, con Rh positivo, contro cui si scatena il sistema immunitario della madre. È grazie a lui che si è sviluppata una sorta di vaccino in grado di prevenire la malattia emolitica del neonato.
Com’è fatto il codice biologico
Come si sa, il gruppo sanguigno è il nostro codice biologico: ci identifica in modo univoco, attraverso le caratteristiche che ereditiamo dai genitori. Le differenze dipendono dagli antigeni, molecole che si trovano sulla membrana dei globuli rossi (o eritrociti) e che il sistema immunitario riconosce come segno distintivo: sa che quei globuli rossi appartengono all’organismo.
Gli antigeni che oggi distinguono i gruppi sanguigni sono nati da antiche mutazioni genetiche e si sono diffusi e mescolati tra i popoli attraverso migrazioni, incroci e adattamenti all’ambiente. I due sistemi principali per determinare il gruppo sanguigno sono AB0 e Rh. Una persona ha:
• un gruppo A o B quando sulla superficie dei suoi globuli rossi è presente rispettivamente l’antigene A o l’antigene B, che funzionano come marcatori di identità;
• un gruppo AB se sono presenti entrambi gli antigeni;
• un gruppo 0 se non ci sono antigeni A o B;
• è Rh positivo se sulla membrana dei globuli rossi si trova l’antigene D, oppure Rh negativo se manca del tutto.
E qui si comprende meglio il contributo di Harrison. Il sistema immunitario di una donna con Rh negativo potrebbe cominciare a produrre anticorpi contro l’antigene D del feto Rh positivo, come se fosse una minaccia. Per evitare questa reazione, i medici somministrano alla madre una profilassi. Si tratta di un’iniezione di immunoglobuline anti-D, ovvero anticorpi già pronti che hanno il compito di eliminare rapidamente eventuali globuli rossi Rh positivi del feto che siano entrati in circolo nella madre, prima che il suo sistema immunitario li riconosca e decida di memorizzarli come nemici. In questo modo, la donna non sviluppa una risposta immunitaria e non produce anticorpi suoi, che potrebbero danneggiare i figli.
La classificazione dei globuli rossi
Il codice del nostro sangue è molto complesso e presenta altri antigeni oltre ai principali. Di solito le trasfusioni funzionano badando semplicemente al fatto che una persona con il gruppo A positivo riceva lo stesso tipo di sangue, idem chi ha il gruppo B eccetera. Ma alcuni hanno gruppi sanguigni molto particolari, difficili da trovare nella popolazione generale.
Quando questi pazienti devono ricevere una trasfusione, non basta trovare sangue compatibile per il sistema AB0 e Rh. Servono globuli rossi con caratteristiche immunologiche quasi identiche alle loro, altrimenti rischiano gravi reazioni avverse da parte del sistema immunitario. Il sangue raro è fondamentale per salvare la vita di queste persone.
«Finora a livello mondiale sono stati individuati 393 antigeni raggruppati in 47 sistemi eritrocitari, ma questa classificazione si arricchisce di continuo», dice Nicoletta Revelli, responsabile del laboratorio di Immunoematologia di riferimento e della Banca del sangue raro del Policlinico di Milano. «Circa il 13% dei pazienti sottoposti a diverse trasfusioni è a rischio di sviluppare una reazione mediata dagli anticorpi che distruggono i globuli rossi del sangue ricevuto».
I donatori che sono come mosche bianche
Chiunque potrebbe avere un fenotipo di sangue raro, come lo chiamano gli esperti, ma magari non lo sa. Proprio come accadde a Harrison, che batté ogni primato oltrepassando la cifra record di 1.100 donazioni nell’arco della sua vita, nella maggior parte dei casi lo si scopre solo quando si diventa donatori di sangue.
«Un donatore è definito di gruppo raro quando il suo profilo antigenico si riscontra nella popolazione con una frequenza inferiore a uno ogni mille individui», spiega Revelli. «La presenza di un fenotipo raro può variare in base all’area geografica e al momento storico: per esempio, i flussi migratori incidono sulla biodiversità degli antigeni presenti nella popolazione».
Per esempio “Rh null”, il cosiddetto “sangue d’oro”, manca di tutti gli antigeni Rh e solo pochissimi donatori al mondo possono fornirlo.
Due soli centri in Italia: Lombardia e Sicilia
Il sangue raro quindi serve per:
• trasfusioni sicure in pazienti che non tollererebbero globuli rossi “normali”;
• preparare terapie specifiche, come le immunoglobuline anti-D (vedi James Harrison);
• conservare scorte di emergenza, spesso a livello nazionale o internazionale, perché quel sangue non si trova sotto casa.
«Uno dei problemi più complessi che un servizio trasfusionale deve affrontare è quello di garantire in tempi brevi la disponibilità di unità di sangue compatibili per chiunque ne abbia bisogno», continua l’esperta. «Ogni anno riceviamo oltre 500 richieste di sangue raro dai centri lombardi e da fuori regione».
Quella milanese, insieme alla Banca regionale degli emocomponenti di gruppo raro della Sicilia, con sede a Ragusa, sono le uniche due realtà riconosciute in Italia, senza le quali preziose sacche di sangue raro andrebbero cercate all’estero. Il gruppo del Policlinico, in collaborazione con il Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità e altri esperti nel settore, sta ora lavorando all’istituzione di una Banca nazionale del sangue raro che possa supportare i singoli servizi trasfusionali locali ed estendere la ricerca e disponibilità di fenotipi rari sul territorio.
Oltre alla visione e alle competenze, per farla funzionare servono però sempre più donatori come James Harrison, affinché raro non sia sinonimo di introvabile.
Il 14 giugno la Giornata mondiale del donatore di sangue
Il 14 giugno è stato scelto come Giornata mondiale del donatore di sangue per ricordare la nascita di Karl Landsteiner, il biologo austriaco che scoprì gli antigeni A, B e 0 del sangue, e il sistema Rh insieme all’immunologo statunitense Alexander Wiener. Il tema di quest’anno è “Il sangue ci unisce” e pone l’accento sul legame tra chi dona e chi riceve.
In Italia la donazione di sangue si appoggia su un atto volontario e non prevede compenso: nel 2023, stando ai dati del Ministero della Salute, hanno offerto il loro braccio oltre 1,67 milioni di italiani, di cui 280mila per la prima volta, e sono state raccolte più di 3 milioni di donazioni tra sangue e altri suoi componenti, come le piastrine e il plasma che viene principalmente utilizzato per la produzione di alcuni medicinali. Sono cifre in lenta ripresa dopo un drastico calo durante il periodo della pandemia da Covid-19 ma non ancora ottimali.
Tra i 18 e i 60 anni di età, tutti possono donare purché godano di buona salute: lo si accerta tramite esami obbligatori e controlli periodici offerti gratuitamente lungo l’iter definito per legge.