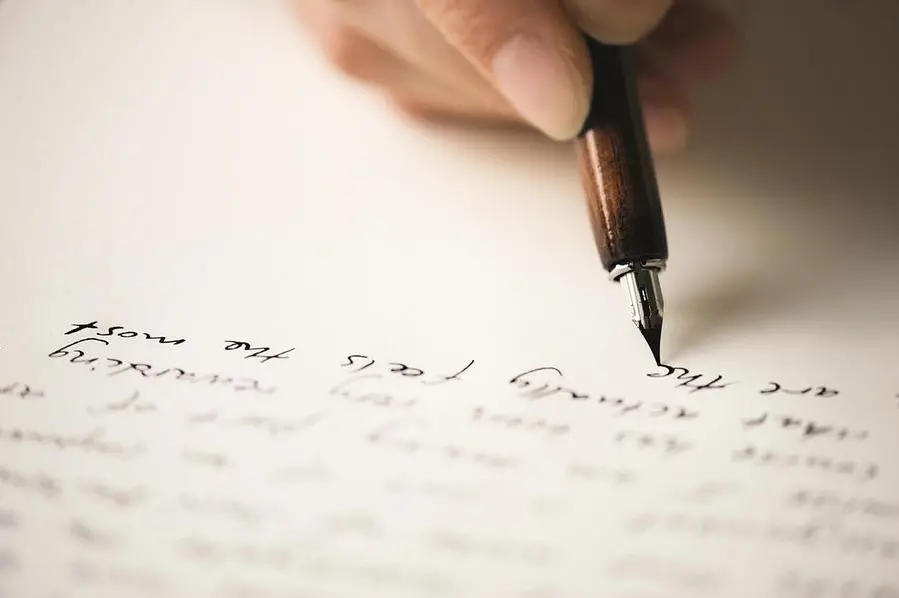PHOTO
Uno studio italiano ha rivelato un dettaglio curioso: la scrittura può risentire di un malfunzionamento della tiroide. Nei pazienti con ipotiroidismo – quando la ghiandola rallenta – la mano diventa più lenta e impacciata, la grafia si fa incerta e, nei casi più severi, si possono dimenticare parole o intere frasi, si legge nell’indagine pubblicata nel 2020 sulla rivista Endocrine.
Pure un’attività eccessiva lascia segni evidenti sulla carta. Nell’ipertiroidismo, infatti, la scrittura si fa nervosa e disordinata: cambiano le dimensioni delle lettere, si alterano spaziature, inclinazioni e perfino la pressione esercitata sul foglio.
«La tiroide è un regolatore fine dell’intero organismo», spiega Giuseppe Marelli, endocrinologo presso l’ospedale di Erba (Como). «Agisce sul metabolismo, sulla mente, sull’umore, sul cuore e addirittura sui riflessi neuromuscolari. Quando funziona in eccesso o in difetto, l’equilibrio complessivo si altera e anche le piccole azioni quotidiane finiscono per cambiare».
I due volti del disequilibrio
Quando la tiroide accelera, l’intero organismo è spinto a correre. «Nelle forme conclamate di ipertiroidismo, i sintomi possono essere intensi e travolgenti», spiega Spyridon Chytiris, endocrinologo all’Istituto Maugeri di Pavia. «Palpitazioni, dimagrimento rapido, tremori, insonnia, nervosismo, sudorazione eccessiva: ogni sistema corporeo sembra andare fuori giri». Tuttavia, trattandosi di sintomi e segni non esclusivi della patologia tiroidea, questi segnali vengono spesso scambiati per ansia, stress o cambiamenti ormonali come quelli tipici della menopausa.
Quando invece l’ipertiroidismo è lieve, i sintomi possono non manifestarsi affatto. È il caso della forma subclinica: il Tsh, ormone prodotto dall’ipofisi che regola l’attività della tiroide, è basso, mentre i livelli dei due ormoni tiroidei, T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), risultano ancora nella norma. «In apparenza, il paziente sta bene», precisa Chytiris, «ma a livello biologico l’organismo è già sotto pressione: aumenta il rischio di aritmie cardiache e osteoporosi. È una fase silenziosa, ma non innocua».
Lo stesso vale in senso opposto per l’ipotiroidismo. Anche qui esistono forme subcliniche, con Tsh elevato ma ormoni tiroidei ancora nei limiti, e forme conclamate, dove i segnali diventano più evidenti. «Aumento di peso, affaticamento, rallentamento mentale, apatia, fino alla depressione», elenca Marelli. «Segni che vengono spesso sottovalutati, perché possono sembrare il prezzo da pagare per una vita frenetica o per un periodo emotivamente difficile».
Origine spesso autoimmune
Nella maggior parte dei casi, sia l’ipertiroidismo sia l’ipotiroidismo hanno un’origine autoimmune. «Nel primo caso, la causa più frequente è il morbo di Basedow-Graves», dice Chytiris. «Il sistema immunitario produce anticorpi che stimolano la tiroide a lavorare senza tregua. È una condizione che può insorgere rapidamente, anche nel giro di poche settimane. In alcuni casi si manifesta un coinvolgimento oculare con occhi arrossati, sporgenti e gonfi, maggiore sensibilità alla luce e lacrimazione accentuata, sintomi legati a una risposta immunitaria che interessa i tessuti perioculari».
Oltre alla forma autoimmune, è importante considerare l’ipertiroidismo associato a patologia nodulare. In questi casi, la condizione tende a svilupparsi più lentamente e i sintomi sono spesso più lievi e graduali. Qui il problema può essere causato da un singolo nodulo autonomamente funzionante (adenoma tossico di Plummer) o da più noduli attivi (gozzo multinodulare tossico).
All’opposto, l’ipotiroidismo è spesso provocato dalla tiroidite di Hashimoto, un altro processo autoimmune ma di segno inverso. «È responsabile di circa il 90% dei casi», precisa Marelli. «Gli anticorpi aggrediscono e progressivamente distruggono il tessuto tiroideo, fino a comprometterne la funzione».
Esistono poi cause meno frequenti, ma non trascurabili: l’uso di farmaci contenenti iodio oppure tiroiditi più spesso virali, che coinvolgono, in seguito a banali stati influenzali delle alte vie aeree, la tiroide e determinano generalmente una temporanea disregolazione della funzione tiroidea.
Nel caso dell’ipotiroidismo, c’è infine una possibilità più rara ma insidiosa. «Una sorta di atrofia spontanea della ghiandola, senza cause evidenti», continua Marelli. «La tiroide si restringe e non riesce più a produrre ormoni a sufficienza». Per questo è importante affidarsi a una valutazione specialistica, soprattutto nei casi meno chiari.
Le analisi del sangue e l’ecografia
La diagnosi passa sempre dal sangue. Il primo indicatore da valutare è il Tsh: se è alto, la tiroide lavora poco; se è basso, lavora troppo. In base a questo valore e ai livelli di T3 e T4, si distinguono le forme subcliniche e ancora prive di sintomi da quelle conclamate. Nei casi sospetti, il passo successivo è il dosaggio degli anticorpi specifici – anti tireoperossidasi (anti-TPO) e anti tireoglobulina (anti-Tg) –, che confermano o escludono un’origine autoimmune del disturbo. Accanto agli esami del sangue c’è sempre l’ecografia, che serve a osservare la morfologia della ghiandola e a rilevare eventuali noduli, alterazioni di volume o segni indiretti di infiammazione.
Le cure migliori
Anche sul fronte delle cure, ipotiroidismo e ipertiroidismo seguono strade opposte ma strutturalmente simili. Quando la tiroide lavora troppo, il farmaco di prima linea è il metimazolo, che inibisce la sintesi degli ormoni tiroidei. «È una terapia molto efficace e ben tollerata, ma non agisce sulla causa del disturbo», spiega Chytiris. «Spegne l’eccesso ormonale. Nel morbo di Basedow, in circa la metà dei casi si ottiene una remissione dopo uno o due anni di trattamento farmacologico».
Diverso è il caso dell’ipertiroidismo da noduli: qui il farmaco viene utilizzato come misura temporanea, in attesa di una terapia definitiva. «La remissione spontanea non è prevista, quindi si pianifica un intervento risolutivo», continua Chytiris. Le opzioni includono la chirurgia (asportazione parziale o totale della tiroide), la somministrazione di iodio radioattivo, che distrugge selettivamente il tessuto iperfunzionante, o tecniche più recenti come la termoablazione, che elimina il nodulo dall’interno tramite una sonda eco-guidata, in modo mininvasivo.
Nel caso opposto, quando la tiroide è pigra, si adotta una terapia sostitutiva. «Si assume levotiroxina, una forma sintetica dell’ormone T4, ogni mattina a digiuno», indica Marelli. «È un trattamento semplice, da seguire per tutta la vita, ma ben tollerato e altamente efficace». Oggi esistono anche formulazioni liquide o in capsule molli, utili per chi ha difficoltà con l’assorbimento o con i tempi di attesa di circa trenta minuti dopo l’assunzione. Il dosaggio viene adattato nel tempo in base ai livelli di Tsh e, una volta raggiunto l’equilibrio, è sufficiente un controllo annuale.
Controllare il Tsh
Anche se le disfunzioni tiroidee possono colpire a qualsiasi età, è dopo i 60 anni che diventano più insidiose. «Negli anziani, l’ipertiroidismo può non dare sintomi evidenti: magari solo un po’ di affanno o stanchezza», spiega Chytiris. «Eppure, proprio in questa fascia di età i rischi di scompensi cardiaci e fragilità ossea sono maggiori». Lo stesso vale per l’ipotiroidismo. «Nei soggetti più avanti con l’età, i segnali vengono spesso sottovalutati», aggiunge Marelli. «Un controllo del Tsh ogni tanto può davvero fare la differenza».
Nel frattempo, impariamo ad ascoltare questa piccola inquilina del nostro organismo. Che sia uno strano tremore sul foglio o una stanchezza difficile da spiegare, la tiroide trova sempre il modo di farsi sentire. «Ascoltarla in tempo significa spesso prevenire complicazioni, curare meglio e vivere con più energia», conclude Chytiris. «Perché, alla fine, come una calligrafia che cambia nel tempo, anche la salute della tiroide lascia un segno visibile. Basta imparare a leggerlo».