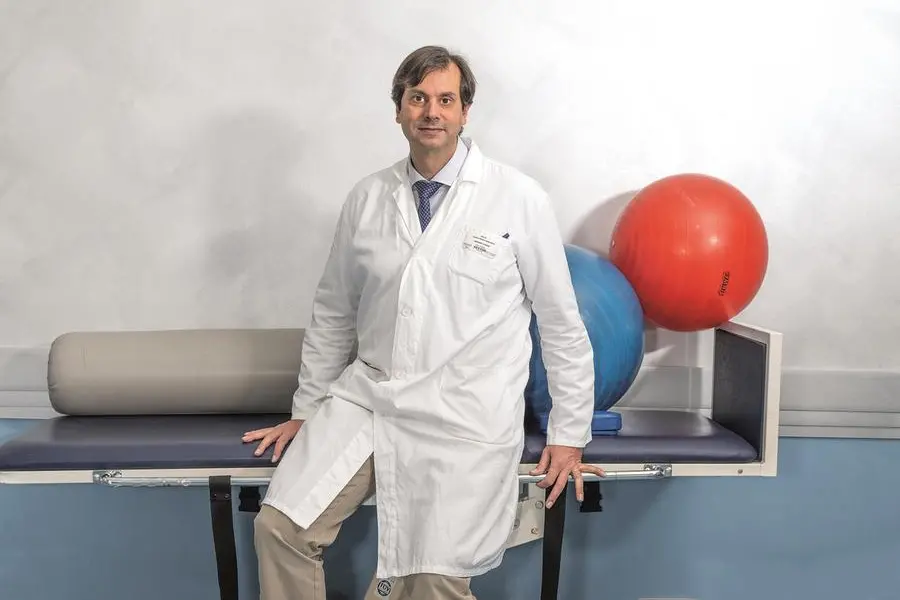PHOTO
Le dita della mano che si intrecciano con quelle della moglie per impugnare una spugna. Gli occhi che seguono attentamente le carte da gioco disposte sul tavolo dal figlio. Il volto che cambia espressione dopo una barzelletta. A 37 anni la vita di Simone (nome di fantasia) è fatta di piccole conquiste quotidiane.
Lo racconta la moglie di Simone mentre mostra un video sullo smartphone a Jorge Navarro Solano, che è responsabile del dipartimento Gravi cerebrolesioni acquisite della Fondazione Don Gnocchi. Qui il paziente è stato assistito durante il percorso riabilitativo per il recupero da uno stato di coma causato da un grave incidente stradale. Nei nove mesi di ricovero ha instaurato con l’équipe sanitaria un forte legame che persiste anche dopo le dimissioni.
«Siamo diventati come una grande famiglia», spiega Navarro. «Seguiamo i suoi progressi anche ora che fa riabilitazione a casa, con l’aiuto del fisioterapista e del logopedista, e interveniamo ogni volta che insorgono nuove problematiche. Cerchiamo di accompagnare i nostri pazienti e le loro famiglie dopo la dimissione, perché la loro felicità non dipende solo dal recupero funzionale e cognitivo, ma anche dal corretto reinserimento nell’ambito familiare e sociale».
Dottor Navarro, quali pazienti arrivano da voi?
«Sono persone di ogni età che hanno subito gravi lesioni cerebrali in seguito a incidenti, ictus o emorragie cerebrali, arresti cardiaci o infezioni, e per questo hanno avuto un coma di almeno 24 ore. Arrivano da noi in stato vegetativo o di minima coscienza, o già emersi dal coma ma ancora non autonomi e presentano gravi deficit cognitivi e comportamentali. Assistiamo più di 800 pazienti con gravi cerebrolesioni all’anno nelle nove unità del nostro dipartimento distribuite sul territorio nazionale».
Il trasferimento nelle vostre strutture avviene quando la fase acuta è ormai alle spalle, ma restano delle criticità dal punto di vista clinico?
«I pazienti arrivano stabilizzati, ma sono comunque molto fragili e complessi: spesso sono portatori di numerosi presidi come cannula tracheostomica, sondino nasogastrico o sonda gastrostomica per la nutrizione enterale, cateteri vescicali e venosi. Per questo li accogliamo in unità attrezzate con un monitoraggio continuo dei parametri vitali che per alcuni aspetti possono assomigliare alle terapie intensive. Stabiliamo poi un forte dialogo con i reparti di fase acuta degli ospedali invianti, in modo da poter affrontare tempestivamente ogni possibile complicanza infettiva o neurochirurgica che possa insorgere durante il ricovero».
Qual è lo stato d’animo dei familiari che si trovano ad affrontare una situazione così difficile?
«La grave cerebrolesione determina un fortissimo trauma psicologico per i familiari, che vedono la propria vita e quella del loro caro cambiare dall’oggi al domani. Nella fase dopo l’incidente si chiedono se il paziente sopravvivrà, ma poi, quando il quadro clinico si stabilizza, inizia lo smarrimento: vogliono sapere se il loro familiare tornerà a parlare, camminare e interagire con loro. Lo shock e il dolore sono talmente grandi che destabilizzano l’intero nucleo familiare. Anche l’andamento altalenante del percorso riabilitativo, con il susseguirsi di buone e cattive notizie, può amplificare lo stress e la sofferenza».
Come li aiutate?
«Cerchiamo di costruire insieme a loro un lavoro di squadra, condividendo il percorso riabilitativo del paziente. Fin dal primo colloquio proviamo a capire quali sono le loro aspettative e cerchiamo di mantenere accesa la speranza seppur con grande cautela, mantenendoci ancorati alla realtà clinica del momento. Per accompagnare la famiglia, indichiamo loro un referente dell’équipe sanitaria (il case manager) a cui possono rivolgersi sempre, per qualsiasi dubbio o chiarimento, e prevediamo colloqui periodici di aggiornamento. Per affrontare le problematiche che potranno emergere nel percorso successivo alla dimissione, li mettiamo in contatto con le associazioni di familiari di pazienti con gravi celebrolesioni e che hanno vissuto esperienze simili e offriamo uno sportello di ascolto che dà supporto psicologico e pratico alle famiglie».


Manuel Cicchetti
Come impostate il percorso riabilitativo dei pazienti?
«Siccome ci muoviamo in un quadro di grande incertezza prognostica, cerchiamo di fissare obiettivi realistici e temporalmente definiti che siano anche misurabili. Per questo elaboriamo un progetto riabilitativo personalizzato attraverso un grande lavoro di squadra che coinvolge medici, infermieri, operatori socio-assistenziali, fisioterapisti, logopedisti, neuropsicologi, terapisti occupazionali e psicologi clinici. L’interdisciplinarietà è cruciale, perché dobbiamo lavorare contemporaneamente su più aspetti: le funzioni vitali, la stabilità clinica, i deficit sensomotori, la comunicazione, la relazione e l’autonomia motoria».
Che strumenti usate per la riabilitazione?
«A quelli più tradizionali affianchiamo strumenti d’avanguardia dal punto di vista diagnostico, come la stimolazione magnetica transcranica con elettroencefalografia ad alta densità e, dal punto di vista terapeutico, sistemi robotici e realtà. La missione della Fondazione Don Gnocchi è offrire non solo assistenza caritatevole, ma anche la migliore scienza e competenza tecnica nella cura e la presa in carico dei pazienti. Per questo puntiamo molto sull’integrazione tra clinica e ricerca, in collaborazione in rete con le società scientifiche, università ed enti di ricerca italiani, europei e statunitensi».
Il percorso di recupero dei pazienti è molto incidentato?
«Ci sono continui alti e bassi che possono essere stressanti per i familiari così come i medici, soprattutto nelle fasi iniziali del percorso riabilitativo. Talvolta le aspettative vengono disattese ed è necessario rivedere il programma prestabilito».
Quanto dura la degenza?
«In genere i pazienti restano da noi almeno sei mesi, anche se la durata del ricovero può variare in base ai limiti imposti dai singoli sistemi sanitari regionali. Il nostro obiettivo è ottenere il miglior recupero cognitivo e neuromotorio possibile, ma sappiamo che alcuni pazienti ci impiegano più tempo di altri e possono ancora fare progressi una volta tornati a casa».
Come vengono vissute le dimissioni?
«Per i familiari rappresentano un momento difficile, una sorta di salto nel buio. Per aiutarli, offriamo loro un programma di addestramento per imparare a gestire il paziente a casa. Inoltre li accompagniamo nello stabilire rapporti con i servizi territoriali di appartenenza, sia per gli eventuali adattamenti ambientali da programmare sia per le future forniture di ausili, la richiesta di contributi assistenziali e la prosecuzione del percorso riabilitativo».
E per quei pazienti che non sono in condizioni di tornare a casa?
«A Palazzolo abbiamo il Nucleo di accoglienza per persone in stato vegetativo, con 30 posti letto per quei pazienti che al termine del percorso riabilitativo presentano disabilità motoria e cognitiva di grado severo e non rientrano al proprio domicilio. In caso di istituzionalizzazione in realtà esterne, diamo ai familiari le indicazioni su quali uffici e persone di riferimento sono incaricate di seguire l’iter amministrativo. Consigliamo inoltre un contatto preliminare con il personale sanitario della struttura di accoglienza in modo che il passaggio ospedale-territorio si realizzi garantendo la necessaria continuità assistenziale».
Il vostro mestiere al fianco dei pazienti è molto duro. Come vi preparate?
«Facciamo molto lavoro di team building con l’aiuto degli psicologi per costruire una squadra solida, anche dal punto di vista emotivo. Per noi è fondamentale sapere che possiamo sostenerci l’un l’altro: le competenze cliniche e tecniche sono fondamentali tanto quanto quelle trasversali, come l’empatia e il problem solving».
Lei è approdato alla Fondazione Don Gnocchi nel 2018 per assistere i pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite. Oggi rifarebbe ancora questa scelta?
«Se non fossi convinto, non farei ogni settimana più di mille chilometri in treno da pendolare per venire qui a Milano partendo da casa mia in Puglia. Per tutti i professionisti che si occupano della cura delle persone con gravi cerebrolesioni e delle loro famiglie è sicuramente difficile lavorare a così stretto contatto con il dolore e la sofferenza delle famiglie, ma spesso non è solo una professione: è una vocazione, che permette di essere un operatore sanitario a 360 gradi. Nel mio caso, credo che sia il posto che il Signore mi ha dato nel mondo. “Accanto alla vita, sempre”, come recita il motto della Fondazione».