PHOTO
Lo psichiatra e psicoterapeuta Piero Cipriano: attualmente si occupa di adolescenti e nuove dipendenze in un Servizio per le dipendenze di Roma
La salute è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, salute mentale inclusa. Ma com’è tutelato in Italia questo diritto per i pazienti psichiatrici? Non bene, secondo Piero Cipriano, psichiatra e psicoterapeuta con un’esperienza trentennale nei servizi pubblici, che ha appena pubblicato il saggio La salute mentale è politica (edizioni Fuoriscena). Il rischio è che la cura degli specialisti si riduca a mera prescrizione di pillole e stesura di protocolli.
Partiamo dal titolo del suo libro: in che senso la salute mentale è politica?
«Nel senso che la psichiatria si è sempre declinata in funzione di un certo tipo di controllo. Quasi mai è riuscita a farlo in modo esclusivamente terapeutico e virtuoso, con lo scopo di liberare le persone dai propri vissuti, dalle proprie sofferenze. In realtà si è espressa attraverso il governo di alcuni sintomi, in modo tale che certi individui fossero poco problematici per la società. Quando la psichiatria si esprime soprattutto nel manicomio - e lo fa per un secolo e mezzo, dagli inizi dell’800 a metà del ‘900 – è perché considera questa l’unica terapia possibile, esercitando una funzione di reclusione per proteggere la società. E non è forse questo un dispositivo politico?».
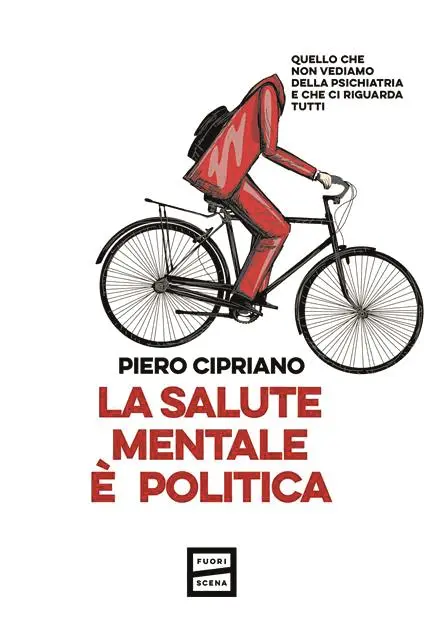
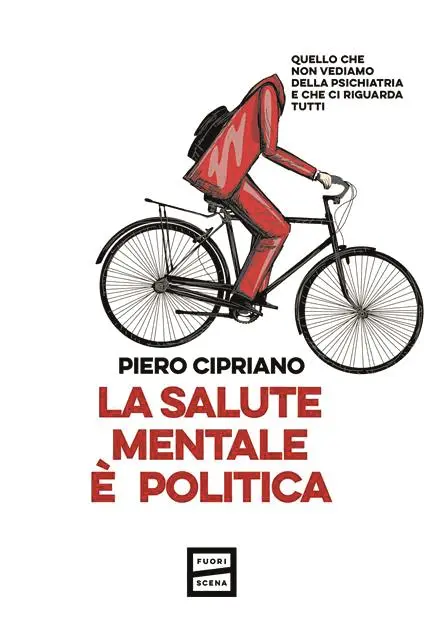
La copertina del saggio di Piero Cipriano, La salute mentale è politica. Quello che non vediamo della psichiatria e che ci riguarda tutti (edito da Fuoriscena)
Ma dopo la chiusura dei manicomi e l’avvento degli psicofarmaci le cose non sono cambiate?
«Non del tutto. In realtà si è passati dalla contenzione fisica (che pure esiste ancora) a una sorta di contenzione chimica. Purtroppo, anche i farmaci sono uno strumento di controllo – anche se più scientifico e più rassicurante – per addolcire i sintomi, ma quasi mai veri strumenti terapeutici. Ancora una volta sono mezzi che controllano, a volte paralizzando il sistema nervoso».
Che cosa ci dovremmo aspettare dunque dalla psichiatria di oggi?
«La psichiatria dovrebbe recuperare il suo etimo, tradito in passato. È un etimo nobile: l’arte di curare l’anima. È questo che dovrebbero fare gli psichiatri: occuparsi della salute psichica delle persone, non del controllo. La psichiatria attuale tende invece a espellere il bisogno di senso e trascendenza, in nome del realismo clinico allineato al realismo capitalista».
Lei scrive di rivoluzione psichedelica mai compiuta.
«Auspico che si rivalutino alcune terapie – prese in considerazione negli anni 50, 60 e 70 – che stanno lentamente tornando alla ribalta. Sono le cure psichedeliche, che espandono la coscienza, allargano la visione».
Le cure psichedeliche consistono nell’uso controllato di sostanze come la psilocibina (principio attivo di alcuni funghi) o l’Lsd per trattare disturbi psichiatrici quali la depressione e il disturbo da stress post traumatico.
«L’assunzione dovrebbe avvenire in contesti clinici, sotto supervisione medica e psicoterapeutica, spesso all’interno di protocolli sperimentali. Si tratta di strumenti terapeutici del tutto diversi da quelli che la psichiatria ha messo in campo di recente e che l’Italia stenta a utilizzare, a differenza di altri Paesi. Non siamo ancora pronti per quello che è stato definito il rinascimento psichedelico».
Nel suo saggio fa spesso riferimento alla dicotomia tra curare con i farmaci e curare con le parole.
«Psicoterapia e terapia farmacologica sono entrambe valide, ma andrebbero riavvicinate e usate insieme, per il bene dei pazienti. La parola andrebbe usata meglio, per andare davvero a pescare nell’ombra delle persone che si rivolgono allo psichiatra, aprendo quel vaso di Pandora dal quale affiora il materiale su cui lavorare. Per fare questo – in modo che la psicoterapia non sia un gesto sterile e interminabile – possono servire i farmaci che permettano allo specialista di lavorare in modo più fecondo, affiancandoli all’uso della parola. I due approcci sembrano divisi ma vanno associati. Lo psichiatra non si dovrebbe chiedere se fare il “pillolaro” o il “parolaio”, ma dovrebbe usare entrambi gli strumenti in modo terapeutico, senza essere ossessionato dal dare un nome alla condizione del paziente, facendo una diagnosi».
Avere una diagnosi, però, è un diritto del paziente, non crede?
«Certo, ed è un diritto che va tutelato. In psichiatria la diagnosi però è un’operazione prevalentemente nominalistica, che mira a mettere un’etichetta a ciò di cui soffre la persona, etichetta che cambia nel tempo mentre la cura tende a rimanere sempre la stessa. Noi psichiatri invece abbiamo il dovere di capire sul serio di che cosa soffrono i nostri pazienti. E non è come nel caso della tubercolosi o dell’osteoporosi, non esistono marker che ci diano risposte certe, aiutandoci a individuare una terapia specifica e fare una prognosi. Non abbiamo marker per la schizofrenia o per la depressione… Le diagnosi in psichiatria sono una sorta di operazione grammaticale: diamo un nome a ogni tipo di sofferenza, e in ogni edizione del manuale diagnostico (Dsm, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, ndr) i nomi si moltiplicano a dismisura, fino ad arrivare oggi a circa 400 diagnosi, probabilmente troppe. Tanto che questo fenomeno viene definito disease mongering, cioè patologizzare la normalità».
Che cosa intende esattamente?
«Voglio dire che arriviamo a definire come fobie sociali stati emotivi fisiologici come la timidezza, oppure a considerare la reazione a un lutto come depressione. Il rischio è quello di iper diagnosticare e poi di iper “farmacologizzare”. È vero, ogni persona ha diritto a una diagnosi, ma ha anche il diritto a non riceverla, quando in realtà si potrebbe dire che il suo è un tipo di sofferenza. Dovremmo prima di tutto tutelare il diritto al dolore, il diritto a soffrire di ciascuno».
Detto altrimenti, ci sono sofferenze che non sono da curare…
«Facciamo un esempio: il lutto. Da Ippocrate fino a Freud è stato considerato come una reazione naturale a una perdita. Questa definizione si è persa successivamente e sulla base dei manuali diagnostici americani i “tempi del lutto” si sono via via accorciati: una volta superati si parla di depressione. Così abbiamo iniziato a definire depresse persone che un tempo avremmo considerato addolorate per una grave perdita. Questo è il venir meno di un diritto, il diritto a soffrire anche per un tempo lungo, il diritto alla tristezza – quella che gli antichi chiamavano melanconia –, che fa parte della vita di tutti noi».
Lei si definisce un basagliano di terza generazione. Come considera lo stato attuale delle strutture di cura psichiatrica in Italia?
«Grazie alla spinta rivoluzionaria di Franco Basaglia, con l’avvento della legge 180, l’Italia è riuscita ad affrancarsi da luoghi come i manicomi, fungendo da modello per gli altri Paesi. Poi, però… Fatta la legge trovato l’inganno. Si sono create una miriade di strutture più piccole che conservano tuttora una dinamica contenitiva: si usa troppo la contenzione. Nella fase acuta della crisi, permane la pratica di allontanare la persona dalla sua casa e dalla sua famiglia, ricoverandola nei reparti ospedalieri di psichiatria, gli Spdc (Servizi psichiatrici di diagnosi e cura), dove spesso i pazienti sono sedati e stanno a letto. D’altro canto, i servizi sul territorio - fuori dagli ospedali - sono carenti in molte Regioni».
Che cosa manca quindi per garantire il diritto a essere curati nel migliore dei modi?
«Bisognerebbe potenziare i Centri di salute mentale sul territorio, che dovrebbero essere tutti aperti 24 ore su 24 (invece su 1.222 Csm esistenti in Italia, solo poche unità lo sono): luoghi in cui si va per essere curati, si sostengono dei colloqui, si seguono le terapie, ma senza venire ospedalizzati. La crisi psichica comporta già di per sé un notevole sconvolgimento interiore. Se poi viene gestita in un luogo chiuso, dove a volte si viene ancora legati al letto, diventa insostenibile, una violazione della libertà della persona. Per attuare questo cambiamento andrebbero stanziati più fondi, certo, ma non è solo una questione di soldi. Serve una nuova attitudine, un salto concettuale, che riveda del tutto quello che si intende per terapia».
Quale dovrebbe essere il ruolo degli psichiatri?
«La psichiatria oggi tende non tanto a proteggere il malato quanto se stessa, dando risposte tipiche di una medicina prettamente difensiva. Noi psichiatri dovremmo invece essere più coraggiosi, meno passivi esecutori. Più soggetti politici e meno tecnici. Essere più informati e aprirci a nuove possibilità terapeutiche, sempre e solo nell’interesse del paziente».






