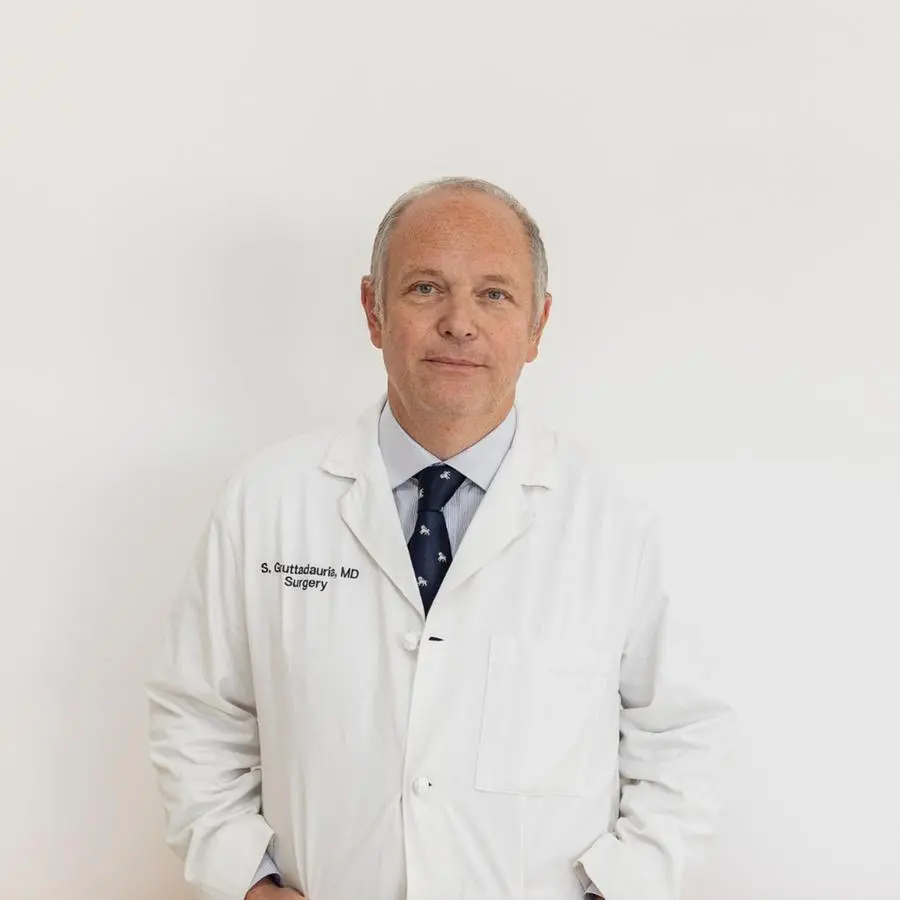PHOTO
In oncologia sono stati già raggiunti risultati eccellenti ed è il momento di migliorare il rapporto medici-pazienti. È l’obiettivo del Collegio dei primari oncologi medici ospedalieri (Cipomo), già presieduto da Luisa Fioretto, prima donna a ricoprire questa carica. A lei e ai suoi colleghi si deve la creazione della Scuola di Scienze umane in oncologia, volta a formare una classe di giovani oncologi, cioè gli specialisti che curano i tumori, che siano “agenti del cambiamento”, più attenti sia alla persona che ha bisogno di terapie sia all’efficacia della cura stessa. Nicoletta L. Bagliano l’ha intervistata per BenEssere.
Che senso ha parlare di umanizzazione in medicina, in particolare in oncologia? C’è forse una carenza di umanità nella vostra disciplina?
«L’attenzione agli aspetti di umanizzazione in medicina nasce da una esigenza più che da una carenza. Mi riferisco all’esigenza di recuperare le origini ippocratiche della nostra professione: parlo del rapporto tra “filotecnia” e “filantropia”, perché là dove c’è amore per l’uomo c’è amore per l’arte medica. Ed è proprio la parte filantropica, di attenzione alla persona, che si è persa nel tempo o più semplicemente nascosta, e che va recuperata».
Perché secondo lei si è persa l’umanità?
«Per ragioni diverse. Prima di tutto c’è un carico di burocratizzazione che si frappone tra il medico e il paziente, che viene considerato un utente più che una persona. Il medico ospedaliero oscilla tra due contratti: il primo con la propria azienda (il servizio sanitario) con vincoli formali ben precisi, e il secondo con il malato che ha di fronte, più coinvolgente e personale. Bisogna ammettere che sempre più spesso il medico è assorbito dal primo, rischiando di trascurare il secondo».
Anche l’iper specializzazione è chiamata in causa?
«In ambito oncologico ci confrontiamo con un’innovazione dirompente, che vede il nostro Paese all’avanguardia, con una sopravvivenza media tra le più alte in Europa. D’altro canto assistiamo a una eccessiva frammentazione della professione. I giovani oncologi escono dall’università preparatissimi ad affrontare la patologia, conoscendone ogni aspetto biomolecolare, ma non sono talvolta in grado di avvicinarsi alla persona che hanno davanti».
Di che cosa hanno bisogno gli oncologi oggi?
«Lavoriamo spesso con ritmi frenetici, stretti da politiche di minutaggio che mal si coniugano con il senso profondo della nostra professione. Una buona relazione terapeutica genera dei valori che non possono essere rendicontati economicamente, ma che hanno un beneficio enorme sulla salute della persona».
Il tempo ha un significato importante in oncologia: per il malato, che teme di averne meno a disposizione, ma anche per il medico…
«Quello trascorso con il paziente deve essere un tempo di qualità, dedicato all’ascolto e alla comprensione, con lo scopo di stabilire una strategia terapeutica efficace ma anche un rapporto di fiducia. Per questo è importante che in oncologia ci sia una continuità relazionale, almeno nei momenti più critici della malattia. E in questa relazione la parola ha un ruolo centrale».
Come si parla a un paziente?
«Prima di tutto si ascolta, dando spazio alle sue paure, che non sono solo legate al timore di soffrire o di morire, ma anche di restare solo o di perdere il lavoro, di non avere nelle mani il timone della propria vita. È essenziale dare legittimità ai suoi sentimenti, che vanno dall’incredulità alla negazione, dall’aggressività al senso di colpa, allo sconforto. Quando comunichiamo una diagnosi di cancro, ci addentriamo in un terreno sconosciuto: sia per il medico che ancora non conosce la persona che ha di fronte, sia per il malato che si trova a dover fare i conti con una notizia che gli cambierà la vita, affrontando un dolore non solo fisico ma anche psichico. Insieme dobbiamo ricostruire l’“adesso” e il “domani”, ridisegnando le aspettative sulla base della realtà, basandoci su una informazione leale».
L’altro compito dell’oncologo è quello di dare speranza…
«Questa è senz’altro la parte più difficile nella relazione medico-paziente. L’oncologo non deve creare illusioni, ma deve dare speranza al malato in termini di prospettiva, qualunque sia la sua condizione clinica. Ciò significa accompagnarlo nei suoi progetti esistenziali, anche nel breve periodo, conservando un orizzonte nell’ambito del quale raggiungere un obiettivo (non importa se parliamo di un mese, di un anno o di un tempo più lungo). Non è l’arco temporale che conta quanto l’orizzonte della propria esistenza, che deve restare aperto. Non sono obiettivi semplici da raggiungere e richiedono abilità comunicative che non necessariamente sono innate, ma si possono apprendere ed esercitare».
È da qui che è nata l’idea di una scuola di umanizzazione delle cure?
«Esatto. La nostra scuola vuole essere una vera e propria palestra per gli oncologi. Qui imparano e allenano competenze che vanno oltre quelle scientifiche, come la disponibilità all’ascolto, la capacità di comprendere il punto di vista soggettivo del paziente e di costruire insieme a lui un percorso nel rispetto dei suoi bisogni e della sua unicità, così come la capacità di creare insieme ai propri colleghi una rete costruttiva ed efficace di lavoro su cui il paziente possa contare. Per questo ci siamo affidati alle scienze umanistiche, inserendo tra i docenti, oltre agli oncologi, anche psicologi, psicoterapeuti, filosofi, sociologi, teologi, esponenti del mondo dell’arte e della letteratura. E chiamiamo anche i pazienti, che vengono a raccontare in aula la loro storia».
Quali sono i benefici per i medici?
«Migliorare la relazione medico-paziente e più in generale il rapporto tra gli operatori sanitari e gli utenti ha un effetto domino positivo su tutto l’ambiente di lavoro ospedaliero, riducendo il livello di stress e di disagio spesso molto forte nei reparti di oncologia, che penalizza sia il medico – esposto ad alti livelli di frustrazione – sia il malato, che avverte il malessere di chi lo sta curando. L’umanizzazione delle cure può quindi essere considerata anche un ottimo antidoto al fenomeno del burnout, a vantaggio di tutti coloro che frequentano le corsie e gli ambulatori».