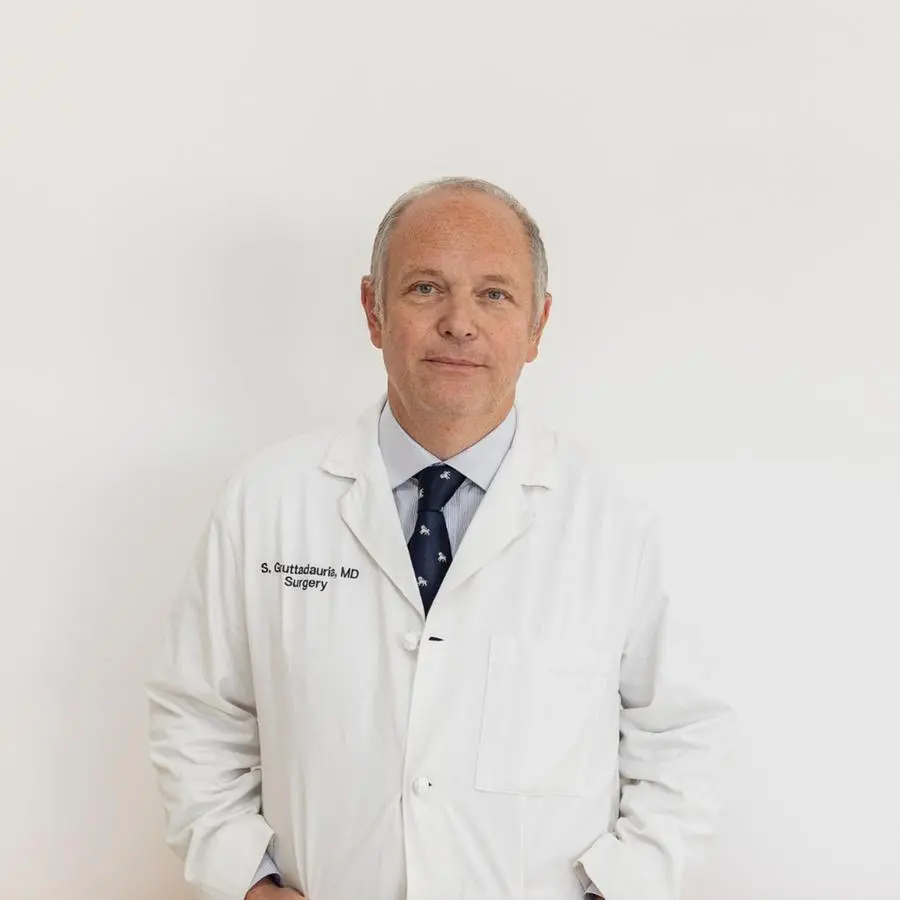PHOTO
Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali, Longevità, Salute e Sport del Comune di Bergamo (foto di Davide Fazio)
Marcella Messina è l’unica tra gli assessori d’Italia ad avere la delega alla Longevità. Dal 2024, a Bergamo. Già chiamarla longevità, invece che invecchiamento o terza età, dà un’idea dell’approccio con cui la giunta vuole affrontare un tema tanto complesso quanto urgente, soprattutto per chi si occupa di politiche sociali. Siamo il secondo Paese più anziano al mondo dopo il Giappone. Già oggi, secondo l’Istat, il 24% dei residenti ha più di 65 anni. E le proiezioni dicono che al 2050 si arriverà attorno al 35%, con un aumento delle persone che vivono in solitudine e, dato non secondario, con un pensionato per ogni lavoratore attivo.
Messina, già assessora alle Politiche sociali con il sindaco Giorgio Gori, riconfermata nel 2024 dalla nuova sindaca, Elena Carnevali, ha deciso di affrontare il problema andando oltre ai luoghi comuni e la drammatizzazione del fenomeno. «Proviamo a ribaltare la prospettiva», dice.
Assessora Messina, come si ribalta la prospettiva sulla vita che si allunga?
«Non consideriamo gli anziani come un problema o un peso ma come persone titolari di un pieno diritto a una vita lunga, attiva e felice. Per questo la delega si chiama Longevità».
Perché era necessario un assessorato alla Longevità a Bergamo?
«Su 120mila abitanti, Bergamo conta 30mila cittadini over 65 e 20mila over 75, un dato che è più alto della media nazionale. Mi è stata data la delega alla Longevità per proseguire un lavoro che l’amministrazione comunale aveva già intrapreso da tempo: un percorso di politiche di invecchiamento positivo».
Come si realizzano queste politiche in concreto?
«Partiamo dall’assistenza. Per gli anziani è fondamentale il contrasto alla solitudine. Abbiamo aperto una Casa di comunità presso l’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII».
Le Casa di comunità sono previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), ma secondo i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe solo il 2,7% è operativo.
«Sono strutture territoriali che abbinano funzioni sociali e sociosanitarie, molto importanti. A Bergamo ne apriremo altre due entro la fine del 2025. Sono un punto di riferimento per offrire cure di base, gestire malattie croniche, dare assistenza infermieristica, facilitare l’accesso a servizi sanitari senza dover andare in ospedale, fornire servizi sociali e attività di prevenzione».
Con chi si rapportano i cittadini?
«Dal 2022 abbiamo gli infermieri di famiglia e di comunità. Hanno un rapporto personale e costante con gli assistiti, che li possono reperire nelle case di comunità, ma anche incontrarli in casa propria. Si raccordano con gli assistenti sociali, così da dare risposte ai molteplici bisogni. Ci sono anche i custodi sociali, nuove figure di supporto territoriale».
Che cosa fanno i custodi sociali?
«Aiutano a orientarsi nei servizi pubblici le persone fragili, per esempio anziani soli, famiglie in difficoltà, disabili, ma segnalano anche situazioni di disagio agli assistenti sociali o alle istituzioni. Sono angeli custodi di quartiere».
Anche puntare sui quartieri rientra nelle politiche di longevità?
«Sì, cerchiamo di programmare tutto in prossimità, coinvolgendo tutti gli abitanti della comunità. Per esempio, i Centri per gli anziani sono diventati Centri per tutte le età. Che non sono soltanto luoghi dove passare un po’ di tempo, magari giocando a briscola. Si promuove il benessere, la cultura. Ci sono iniziative che vanno dal teatro ai corsi di formazione e ai laboratori per la riqualificazione professionale. Abbiamo anche coinvolto giovani geriatri, che fanno interventi per sensibilizzare sui temi della prevenzione e dell’attività fisica. E il mercoledì ci si ritrova per il pranzo conviviale di comunità».
La vecchiaia non è uguale per tutti. C’è chi ha più risorse, più appoggi e chi meno.
«Certo, l’età che avanza può anche aumentare le diseguaglianze sociali, non solo in termini di reddito o di abitazione, ma di povertà di relazioni, nel senso che gli anziani hanno una rete di amici e di familiari che tende a ridursi. Come amministrazione abbiamo messo in campo delle iniziative. Da quest’anno, per esempio, abbiamo ridotto del 20% la quota di spesa che gli anziani senza una rete familiare devono pagare per ricevere l’assistenza domiciliare. Normalmente l’assistenza a casa viene concessa in base all’Isee, che misura solo il reddito e il patrimonio, ma non tiene conto di chi vive solo o non ha nessuno che possa aiutare».
L’estate è una stagione che per gli anziani soli può essere difficile.
«Dal 2023 abbiamo rimesso in funzione i Centri ricreativi estivi per gli anziani, che hanno un successo straordinario. Sono aperti dal primo luglio al 5 settembre. Gli anziani vanno con un servizio dedicato di taxi gratuito. Abbiamo moltissime attività culturali, laboratori, gite, giochi».
Voi collaborate con l’Università di Bergamo.
«Esatto. Nel 2024 insieme a rappresentanti dell’ateneo siamo stati a Newcastle, dove c’è un importante centro multidisciplinare che studia la longevità, il National Innovation Center for Ageing, e siamo entrati nella rete internazionale City of longevity, dove si confrontano amministrazioni locali, studiosi, architetti, per progettare politiche innovative legate alla longevità. Un laboratorio d’innovazione sociale che ci stimola ad andare avanti su questa strada».
Prossimi obiettivi?
«Il Comune lavora insieme all’Università per capire come usare le nuove tecnologie per aiutare le persone a vivere più a lungo e meglio. Abbiamo già costruito una piattaforma digitale che mette in contatto online cittadini disponibili ad aiutare gli anziani soli, un servizio di solidarietà. Stiamo anche avviando progetti di co-housing per anziani, cioè case o appartamenti condivisi da più persone anziane. In questi alloggi vengono usate soluzioni tecnologiche come domotica, per rendere la casa più comoda e sicura, teleassistenza e telemonitoraggio, per controllare a distanza lo stato di salute».