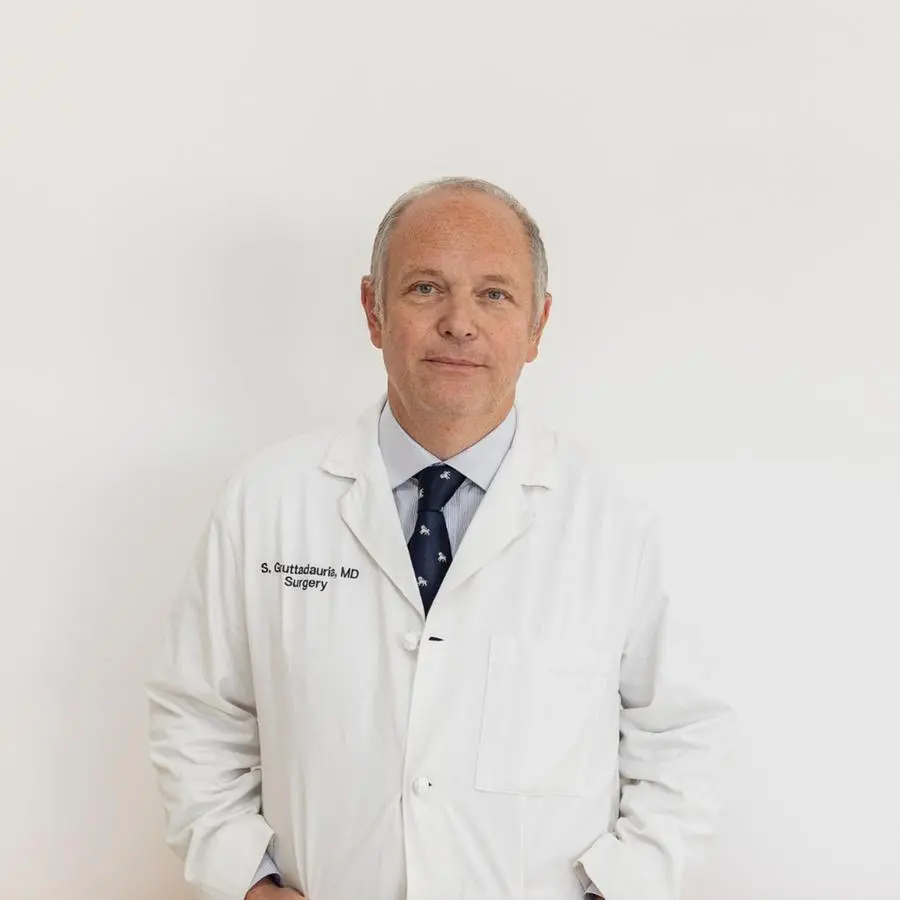PHOTO
Le “grandi dimissioni”, the great resignation, secondo la definizione dello psicologo britannico Anthony Klotz, sono state un campanello d’allarme. Negli Stati Uniti durante la pandemia da coronavirus, e in seguito in Europa, un numero straordinariamente alto di lavoratori dipendenti, soprattutto giovani tra i 26 e i 35 anni, ha scoperto che c’erano modi differenti di conciliare la vita con la necessità di lavorare, e si è licenziato. Chi mettendosi in proprio, chi accettando lavori saltuari, chi puntando sulle opportunità offerte dallo smart working.
In Italia il picco raggiunto nel 2022, con oltre due milioni di dimissioni volontarie, è stato confermato nel 2023 e nel 2024. Ma chi analizza i fenomeni sociali ritiene che non si tratti di un evento contingente. Il tasso di dimissioni nelle società economicamente più avanzate, infatti, continua a essere superiore alla media storica, indice di una crescente insoddisfazione per quello che una volta era l’ambìto posto fisso. Secondo le indagini dell’Osservatorio Hr innovation practice, del Politecnico di Milano, solo il 9% degli italiani afferma di stare bene nell’impiego attuale e appena il 5% si considera felice al lavoro.
A occuparsi di questo tema è stata, nel suo ultimo libro, Francesca Coin, sociologa, fino al 2022 docente nel dipartimento di Sociologia dell’Università di Lancaster, nel Regno Unito, ora al dipartimento di Economia aziendale, sanità e sociale (Deass) dell’Università Supsi di Lugano. Il libro si intitola Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita (Einaudi, 2023). «Ci hanno sempre ripetuto che il lavoro è ciò che ci definisce, il fondamento della nostra dignità di esseri umani. E allora perché, in tutto il mondo, sempre più persone si dimettono?», si chiede retoricamente nel saggio. La risposta è che il lavoro sta attraversando una crisi strutturale. In cui da una parte c’è la tendenza alla compressione dei redditi e delle garanzie, dall’altra la crescente indisponibilità a sottostare alle regole vessatorie imposte da numerosi contesti lavorativi. Sono temi di cui Coin parlerà al Festival internazionale dell’Economia, a Torino dal 30 maggio al 2 giugno con la direzione scientifica di Tito Boeri.


Sociologa e docente universitaria all’Università Supsi di Lugano, Francesca Coin si occupa di lavoro e diseguaglianza sociale. Il suo libro recente si intitola Le grandi dimissioni (Einaudi, 2023). È ospite del Festival internazionale dell’economia di Torino domenica 1 giugno alle 16 in piazza Carlo Alberto, con Ginevra Lamberti e Riccardo Staglianò.
Con l’affermarsi delle politiche economiche neoliberiste, le aziende hanno avuto sempre più mano libera in termini di flessibilità, bassi salari, pressioni sul lavoratore. Si può dire che si è rotto quel patto implicito che regolava il lavoro, per cui il dipendente vi si dedicava con impegno ma in cambio aveva prospettive di carriera, sicurezza, rispetto del suo ruolo?
«Direi di sì. Le politiche di deregolamentazione, unite alla richiesta di maggiori performance, hanno impattato in particolare su alcuni settori. Penso soprattutto al terziario, alla ristorazione, commercio e servizi. Mentre una certa parte della manifattura è rimasta un po’ protetta. Quei settori sono infatti quelli più segnati dalla disaffezione. Un fenomeno che si traduce anche in ricadute negative per le aziende, che fanno fatica a reclutare o trattenere i dipendenti».
Alla fine si sta mostrando corretta l’analisi di Marx, secondo cui il lavoro dipendente è alienazione? E se fosse così, perché starebbe diventando evidente solo adesso?
«Sì, è che adesso i nodi vengono al pettine in modo più manifesto. Anche perché negli ultimi 40 anni i sindacati hanno progressivamente perso capacità di incidere. E così il malessere lavorativo si è medicalizzato, con l’aumento dei burnout (esaurimento fisico e mentale causato da stress sul lavoro, ndr), del consumo di psicofarmaci, dell’alcolismo. Il malessere è diventato un problema medico. Le dimissioni sono un altro modo di tentare di risolvere il problema. Negli anni 70 l’alienazione si affrontava invece in modo collettivo».
I dati dicono che l’Italia è l’unico Paese in Europa dove le retribuzioni sono calate in termini reali, rispetto al 1990. Se la retorica del lavoro come missione non convince più, forse è soprattutto perché l’impiego non dà più prospettive economiche.
«In Italia ci sono state perdite di potere d’acquisto straordinarie a cui si aggiunge la progressiva privatizzazione in settori che un tempo erano garantiti, come la sanità. C’è un deterioramento complessivo. Per le giovanissime generazioni oltre ai problemi motivazionali c’è quello di far quadrare i conti. La parola “prospettive” è ridotta al minimo».
L’antropologo David Graeber scriveva che nelle società post industriali una buona parte dei lavori sono diventati privi di senso, inutili per la società: per esempio, quelli nel cosiddetto terziario avanzato, nel marketing, nella finanza. È d’accordo?
«In parte. Lui sosteneva che ci sono lavori che non hanno senso intrinsecamente. E questa è una posizione molto forte, che ha contribuito ad aprire un dibattito ed è stata anche criticata. Io avrei una posizione meno categorica, perché il senso del lavoro, lo dicono anche i sondaggi, ha una componente inevitabilmente soggettiva.
E l’economista Maynard Keynes 100 anni fa diceva che entro questo secolo, grazie ai progressi della tecnologia, la settimana lavorativa sarebbe stata di 15 ore. L’automazione, compresa quella dell’intelligenza artificiale, in effetti fa sempre più cose, ma il tempo lavorativo non sta diminuendo.
«Il potenziale per lavorare meno c’è. Il problema è che la tecnologia non libera le persone. La tecnologia oggi non è pensata per liberare il tempo o creare stili di vita sostenibili, è pensata per abbassare il costo del lavoro e creare profitti. Il risultato è inevitabilmente che lavoriamo di più, guadagniamo di meno e non vediamo il senso di quello che stiamo facendo».
Come dovrebbe cambiare il lavoro per tornare al centro delle aspirazioni delle generazioni più giovani?
«Il lavoro va inteso come la nostra capacità di cambiare il mondo, di trasformare la società. Dovrebbe quindi essere guidato da una visione di futuro. Pensiamo a tutto ciò di cui c’è bisogno oggi, a partire dalla transizione ecologica o dalla possibilità di immaginare una società fondata sulla cura. Il lavoro dovrebbe avere un’utilità collettiva molto forte, dovrebbe rispondere alle esigenze delle persone. Le nuove generazioni un po’ questa sensibilità la mostrano, spesso lasciano aziende fortemente impattanti dal punto di vista ambientale e ne cercano una che corrisponda ai propri valori».
Sono obiettivi importanti e a lungo termine. Ci sono nuove modalità di lavoro che potrebbero essere sperimentate ora?
«Nel breve e medio periodo dobbiamo ragionare per forza sulla riduzione del tempo di lavoro e sull’aumento dei salari. Poi c’è il tema del costante monitoraggio della performance, che vediamo in molti lavori digitali e soprattutto nei rider, i lavoratori che fanno consegne, soprattutto di pasti, in bicicletta o motocicli nelle grandi città: sono lavoratori gestiti da un algoritmo, un sistema che ha un forte impatto sulla salute. Tutto questo andrebbe rivisto completamente».