PHOTO
Per secoli, la medicina ha avuto mani femminili e nomi maschili. Prima ancora che esistessero università, camici e titoli, erano le donne a curare: nei campi, durante il parto, accanto ai letti dei malati. Preparavano rimedi, riconoscevano i sintomi, sperimentavano piante e sostanze. Un sapere antico, tramandato di generazione in generazione, che ha gettato le basi della medicina moderna. Eppure, di questa lunga storia resta pochissimo nella memoria ufficiale.
È da questa rimozione che prende spunto Medicina femminile plurale (Bollati Boringhieri), il libro di Daniela Minerva, direttrice responsabile della piattaforma «Salute», online e in edicola con la Repubblica e La Stampa. La giornalista ricostruisce un filo spezzato: quello che lega le raccoglitrici di erbe alle farmacologhe, le levatrici alle ginecologhe, le alchimiste alle scienziate moderne. Un filo che attraversa i secoli, mostrando come il contributo delle donne non sia stato affatto marginale o occasionale, ma strutturale.


Daniela Minerva, direttrice responsabile della piattaforma «Salute», online e in edicola con la Repubblica e La Stampa
Daniela Minerva, nel suo libro scrive che le donne hanno curato molto prima di essere riconosciute come figure mediche. Perché questo sapere è stato a lungo dimenticato?
«Perché era un sapere senza riconoscimento ufficiale, legato alla vita domestica e alla cura quotidiana, ambiti storicamente affidati alle donne. Gestire gravidanze, nascite e cura dei figli era un vero e proprio mestiere, soprattutto in epoche in cui partorire era rischioso e far sopravvivere un bambino era tutt’altro che scontato. Tutto ciò che avveniva nelle case non entrava nella storia della medicina, anche se erano le donne a tenere in salute il mondo più vicino a loro, usando piante, erbe, radici commestibili e rimedi pratici».
Che tipo di conoscenza era quella femminile?
«Era empirica, basata sull’osservazione diretta e sull’esperienza quotidiana. Per secoli, tutta la medicina si è basata su pratiche tramandate, prima che Ippocrate, nel V-IV secolo avanti Cristo, la strutturasse come sapere razionale attraverso l’individuazione delle cause delle malattie. La medicina scientifica moderna si è costruita proprio su questo patrimonio pratico, in gran parte custodito dalle donne, senza il quale molte innovazioni e terapie non sarebbero state possibili».
Nel mondo antico il confine tra medicina, magia e superstizione era molto sottile. Chi stabilisce, storicamente, cosa diventa medicina “legittima”?
«A stabilirlo sono i rapporti di potere e le istituzioni. Con la medicina ippocratica nasce l’idea di trasformare la cura in conoscenza razionale, con regole e principi teorici. Ma questo passaggio avviene in scuole, università e corporazioni dalle quali le donne sono inizialmente escluse. Così, nel processo di istituzionalizzazione, gran parte del sapere pratico accumulato nei secoli resta fuori: ciò che diventa “medicina legittima” è deciso più dai rapporti sociali che dalla scienza».
Quindi nei trattati antichi il sapere femminile non compare mai?
«In realtà, non è del tutto assente, ma compare in modo indiretto. Negli scritti ginecologici del V-IV secolo a.C., gli autori uomini riportavano pratiche utilizzate dalle donne, senza però analizzarle o spiegarle. Queste conoscenze entravano così nei trattati ippocratici, rimanendo tuttavia un sapere separato, come se non appartenesse alla competenza dei medici né fosse per loro pienamente accessibile».
Tra le prime donne a distinguersi lei cita Joanna Stephens.
«Era una farmacologa del XVIII secolo, che sperimentava rimedi naturali nel suo piccolo ospedale di Londra. È famosa per essere stata la prima donna a ricevere un riconoscimento ufficiale per un’invenzione: il Parlamento inglese le corrispose 5.000 sterline per la sua formula a base di gusci d’uovo, sapone e miele, capace di sciogliere i calcoli renali».
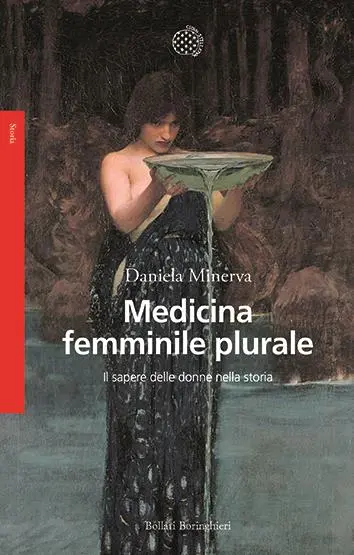
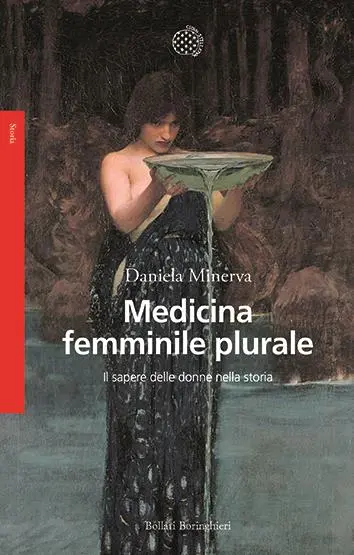
Medicina femminile plurale. Il sapere delle donne nella storia (Bollati Boringhieri), il nuovo libro della giornalista e saggista Daniela Minerva
Per tutte le altre, bisogna aspettare più tardi?
«Sì. In Italia, fino ai decreti di Ruggero Bonghi e Michele Coppino del 1875-1876, le donne non potevano laurearsi e quindi praticare medicina ufficialmente. Nel resto del mondo, pioniera fu la britannica Elizabeth Blackwell, che nel 1849 si laureò negli Stati Uniti nonostante i pregiudizi. Non solo diventò medico, ma fondò ospedali e scuole di medicina per donne, dimostrando che la professione poteva essere accessibile anche a loro».
Prima di allora non ci sono state figure di spicco?
«C’erano ostetriche come la francese Marie-Anne Boivin nell’Ottocento. Assisteva i parti, scriveva trattati, progettava strumenti innovativi – come uno speculum meno doloroso – e gestiva ospedali, trasformando l’esperienza pratica in vera scienza. Ma è solo dalla fine dell’Ottocento in poi che inizia il grande afflusso di donne nelle università e nella professione medica, un vero “tsunami” che oggi le vede numerose».
Quanto numerose?
«Secondo i dati 2025 della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, circa un terzo delle posizioni di vertice nelle aziende sanitarie è occupato da donne: il 23,8% dei direttori generali e il 32,1% dei direttori sanitari. Nel settore farmaceutico, tra il 2018 e il 2023 la presenza femminile è cresciuta del 14%: oggi le donne sono circa il 45% degli addetti e il 47% ricopre ruoli di responsabilità. Tuttavia, il vertice massimo resta una soglia difficile: meno del 10% dei grandi gruppi farmaceutici e biotecnologici è guidato da una donna, anche se qualcosa si muove, come dimostra la nomina di Julie Kim alla guida di Takeda, con effetto dal giugno 2026. Sarà la prima donna a capo di una Big Pharma».
È vero che fa eccezione l’oncologia?
«In parte sì. Oggi le donne sono la maggioranza tra gli oncologi in Italia (circa il 63%) e superano il 50% anche in Europa, ma restano poche nei ruoli decisionali: nel nostro Paese solo 23 primari su 154 sono donne, in Europa meno del 36%, e nelle grandi organizzazioni di ricerca oncologica appena il 15% ha una leadership femminile. È una disciplina ancora molto gerarchica e legata a protocolli rigidi. Eppure, dove le donne guidano reparti o studi clinici – come nelle breast unit o nei trial sui tumori ginecologici – si osservano più attenzione alla qualità della vita, terapie più mirate e, in alcuni casi, migliori esiti clinici».
In Italia, ci sono figure femminili che hanno concretamente cambiato la pratica oncologica?
«Un esempio è Lucia Del Mastro, oggi alla guida della Clinica di Oncologia medica del Policlinico San Martino di Genova. Dopo essere diventata madre di due gemelli, nel 2000, ha avvertito con forza la necessità di intervenire su un problema fino ad allora poco considerato: la possibilità, per le giovani donne sottoposte a chemioterapia, di preservare la fertilità. Da qui lo sviluppo di protocolli specifici che hanno cambiato la pratica clinica, introducendo una maggiore attenzione alla qualità della vita futura delle pazienti».
In generale, le donne hanno portato qualcosa di nuovo nei vari settori oppure si sono dovute adattare a modelli già esistenti?
«Le donne portano sempre innovazione. Un esempio chiaro è la cristallografia, la disciplina che studia la struttura della materia e che, grazie ai raggi X, permette di “vedere” come atomi e molecole sono organizzati. Nel Novecento Dorothy Hodgkin ha usato questo strumento per comprendere la struttura della penicillina, dell’insulina e della vitamina B12, rendendo possibile il loro uso come farmaci. Rosalind Franklin, invece, ha reso visibile per la prima volta la doppia elica del Dna. Non si sono adattate a modelli già dati: li hanno trasformati, aprendo strade nuove».
Guardando a questa lunga storia, cosa rischieremmo di perdere se considerassimo la medicina come un sapere neutro?
«Rischieremmo di curare male. L’universalità astratta cancella le differenze reali e questo produce disuguaglianze. Una medicina che non riconosce la pluralità dei corpi è una medicina meno efficace».
C’è qualcosa che accomuna tutte le donne di cui lei parla nel libro, al di là delle epoche e dei contesti storici?
«Sì, la resilienza, la capacità di pensare fuori dagli schemi e la fiducia in sé stesse. Durante la Seconda guerra mondiale, la filosofa Simone Weil ideò un progetto per formare infermiere da mandare al fronte, dove normalmente le donne non erano inviate, e sottolineava che l’unico rischio era che perdessero coraggio o che si conformassero a ruoli subalterni. La sua conclusione è semplice e chiara: volontà e determinazione permettono alle donne di superare ogni ostacolo e questo filo di testardaggine lega tutte le donne che ci hanno precedute, anche in periodi in cui era loro negato perfino il diritto di studiare e di pensare liberamente».









