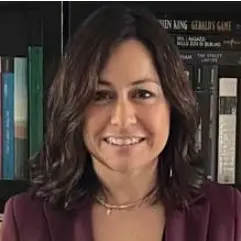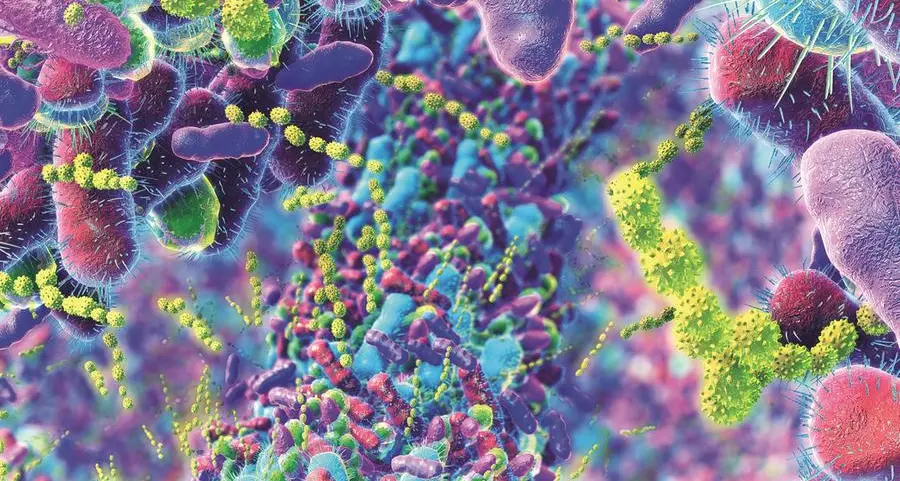PHOTO
È una questione di priorità. Chi ha dei sintomi preoccupanti, o una patologia che dev’essere trattata il prima possibile, ha il diritto di fare visite specialistiche, esami e cure prima degli altri. Purtroppo, le cose non vanno sempre per il verso giusto.
Le lettere sulle prescrizioni
Una legge che fissa per il Sistema sanitario nazionale tempi massimi per erogare visite e accertamenti diagnostici c’è dal 1998. Poi, con il Piano nazionale 2010-2012 per il governo delle liste d’attesa, sono stati introdotti dei codici, da riportare nelle ricette, che assegnano le priorità delle prestazioni. Quando il medico prescrive una prima visita specialistica, un esame diagnostico o un intervento, indica sulla ricetta un codice (una lettera) che stabilisce il tempo massimo entro cui la prestazione dev’essere eseguita.
• U. Per i casi da trattare tempestivamente c’è la lettera U (urgente): indica che la prestazione va eseguita entro 72 ore. In questo caso bisogna prenotare entro 48 ore dall’emissione dell’impegnativa. Se non si è prenotata la prestazione entro due giorni, la prescrizione resta valida ma si perde l’urgenza garantita dal codice.
• B. La lettera B (breve) indica che possono passare al massimo 10 giorni per la visita o l’esame.
• D. La lettera D (differibile) è il codice usato per dire che le visite vanno effettuate entro 30 giorni e gli esami entro 60 giorni.
• P. La P (programmabile) significa che la prestazione dev’essere effettuata entro 120 giorni.
Il codice è assegnato dal medico sulla base della valutazione clinica del paziente. Per esempio, una sospetta patologia oncologica o un’insufficienza cardiaca potrebbero richiedere una visita urgente, con codice U, mentre un controllo di routine potrebbe rientrare nella categoria P.
I simboli per l’ospedale
Diverse classi di priorità sono previste anche per i ricoveri ospedalieri:
• A, per un’attesa massima di 30 giorni;
• B di 60 giorni;
• C di 180 giorni;
• D di 12 mesi.
Per prenotare l’esame o la visita prescritta, il paziente può andare di persona al Centro unico di prenotazione (Cup) della propria Asl, al centro prenotazione di una struttura sanitaria, telefonare al centralino regionale dedicato, o usare i canali online, compreso, in alcune Regioni, il Fascicolo sanitario elettronico.
I dati spaventosi dei ritardi
Il problema è che, nonostante i tentativi di risolvere il problema a livello legislativo e le iniziative delle Regioni (a cui è delegata la gestione territoriale della sanità), la maggior parte delle Asl non è in grado di garantire i tempi adeguati.
Dati significativi sono quelli che emergono dall’ultima indagine di Cittadinanzattiva, associazione di promozione sociale che nel 1980 ha fondato il Tribunale per i diritti del malato, e che sull’argomento ha in corso una campagna di sensibilizzazione: “Stop attese”.
Nel Rapporto civico 2024, basato su segnalazioni dei cittadini, risulta che per una prima visita dermatologica o gastroenterologica urgente ci si può sentire rispondere che ci vogliono 98 giorni d’attesa, anziché le 72 ore massime previste. Per quanto riguarda le visite che hanno una classe B (entro 10 giorni), le attese arrivano a 180 giorni per la prima visita urologica, 127 per la prima visita di chirurgia vascolare e 120 giorni per la prima visita oculistica. Per le visite classificate con priorità D (entro 30 giorni), sono state riferite attese di 300 giorni per una prima visita cardiologica e neurologica, 282 per una pneumologica e 250 per una visita oculistica. Il record è stato raggiunto dai 468 giorni per una prima visita oculistica e dai 300 giorni per prime visite pneumologiche e neurologiche.
La criticità è stata confermata da un’ulteriore indagine, realizzata raccogliendo i dati da siti web regionali e delle Asl di otto Regioni, aggiornati al 2 aprile 2025. Ne emerge che in nessuna delle Regioni esaminate (Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria) i tempi vengono rispettati.
Le liste chiuse? Vietate
«Il Cup in genere propone di fissare l’appuntamento più avanti», spiega Isabella Mori, responsabile Tutela e politiche per la trasparenza di Cittadinanzattiva, «ma succede, spesso, che dica che non c’è posto, che non possono fissare alcun appuntamento né nella struttura scelta, né in alcuna nel raggio di 125 chilometri, quello entro il quale per legge devono essere fornite le prestazioni. Sono le cosiddette liste chiuse, che sarebbero vietate».
La nuova norma
Le norme, rafforzate dalla legge 107 del 29 luglio scorso, prevedono che, se il Cup non offre un appuntamento entro i tempi stabiliti nell’impegnativa, il paziente ha il diritto di chiedere che la prestazione venga offerta in regime privato presso le strutture pubbliche pagando solo l’eventuale ticket, o in una struttura privata convenzionata, on costi a carico della Asl, sempre salvo l’eventuale ticket. «Purtroppo raramente lo fanno», spiega ancora Mori. «Con le nuove norme sono state previste sanzioni amministrative per le Asl inadempienti, sono stati attivati meccanismi per il monitoraggio delle liste d’attesa regionali ed è diventato obbligatorio uniformare le agende, che vuol dire che i Cup devono poter vedere le disponibilità in tutte le strutture, sia le pubbliche sia le private convenzionate, cosa che oggi non avviene. Sono provvedimenti che potrebbero migliorare la situazione, ma ci vuole tempo e, soprattutto, non tutte le Regioni sono in grado di adeguarsi allo stesso modo».
Il paziente a cui non sono stati garantiti i tempi della ricetta ha anche la facoltà di rivolgersi direttamente al regime privato. L’iter non è agevole. Se, dopo aver presentato una richiesta scritta al direttore generale dell’Asl di riferimento, non riceve risposta a stretto giro e con un appuntamento più ravvicinato, l’assistito può rivolgersi direttamente alle prestazioni in libera professione e fare poi richiesta di rimborso della spesa.
Con chi protestare
In ogni caso l’importante, secondo Mori, è che il cittadino a cui viene negato il diritto a una prestazione nei tempi adeguati non sia passivo, ma pretenda che gli vengano offerte soluzioni alternative e, se questo non avviene, che sporga un reclamo. I destinatari possono essere la direzione sanitaria, la direzione generale o l’ufficio relazioni con il pubblico della propria Asl, o ancora l’assessorato alla Sanità della Regione.