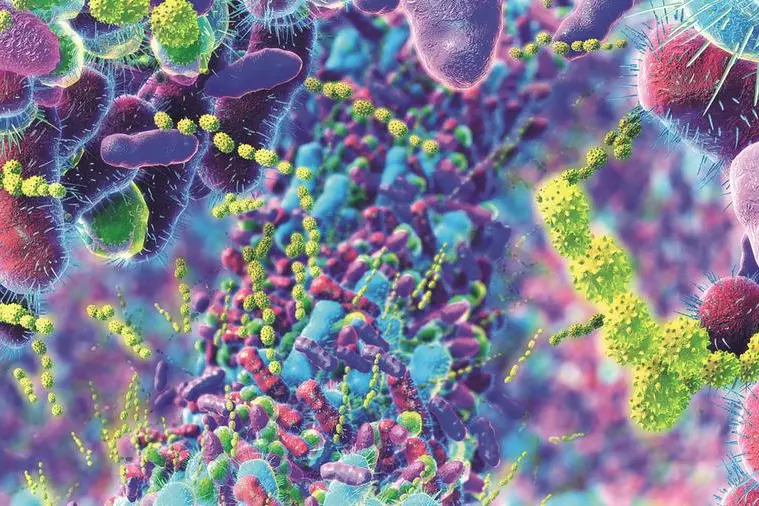PHOTO
Un immagine del microbiota intestinale, insieme di miliardi di microrganismi
In guerra ci sono nemici invisibili che possono uccidere più delle bombe e alleati altrettanto invisibili che possono salvare vite. Il medico tedesco Alfred Nissle lo intuì nel 1917, durante la Prima guerra mondiale, quando conobbe un sottoufficiale scampato a una grave infezione batterica intestinale che aveva decimato i suoi commilitoni durante una campagna militare nei Balcani. Nissle ipotizzò che l’arma segreta di quel soldato fosse nell’intestino e così decise di analizzare un campione delle sue feci, dalle quali isolò un ceppo batterico benefico in grado di contrastare l’infezione. In suo onore venne denominato Escherichia coli Nissle 1917, uno dei primissimi probiotici che ha poi avuto un tale successo nella pratica clinica da essere ancora oggi tra i ceppi più utilizzati contro i disturbi intestinali.
A più di un secolo di distanza, i probiotici si trovano ormai nelle case di milioni di italiani, nascosti nei vasetti in frigo così come nelle capsule e nei flaconcini degli integratori. Promettono di agire sul microbiota (un tempo chiamato flora batterica) per regolarizzare il transito e sgonfiare la pancia, salvare le vacanze dalla dissenteria e promuovere il recupero dopo una terapia antibiotica. Il loro impiego è così diffuso che i probiotici sono da anni in testa alla classifica dei supplementi più venduti nelle farmacie, con un mercato che in Italia vale più di 500 milioni di euro.
Tutto questo per dire che ci sono dei probiotici con un potenziale terapeutico, perché riescono a riequilibrare la popolazione batterica in positivo. È importante, però, che in caso di determinate patologie li consiglino i gastroenterologi. In farmacia e al supermercato si trovano una moltitudine di prodotti, ma acquistare una confezione qualsiasi forse non aiuterà a risolvere il problema.
Non sempre gli interessi commerciali corrispondono a benefici documentati e la disinformazione galoppa, specie sui social media. «Uno studio del 2023, che ha analizzato cento video di YouTube sui probiotici, ha rilevato che il 95% promuoveva un atteggiamento positivo nei confronti del loro consumo, con molti più contenuti prodotti da influencer che da esperti», ha denunciato in un recente editoriale del Washington Post la gastroenterologa Trisha Pasricha, docente di medicina alla Harvard Medical School di Boston.
Per non cadere nella rete, cerchiamo di fare chiarezza sulla base delle evidenze scientifiche disponibili. Ecco le risposte ai quesiti più comuni con l’aiuto della gastroenterologa Lucrezia Laterza, ricercatrice presso la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma.
Cosa sono i probiotici?
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, i probiotici sono «microrganismi vivi che, quando assunti in quantità adeguate, possono apportare benefici alla salute dell’ospite». Questa definizione, un po’ generica ma condivisa a livello internazionale, risale al 2001 e introduce un aspetto cruciale: i microrganismi, in genere batteri ma anche lieviti, devono rimanere vitali per tutto il tragitto dalla bocca all’intestino, in modo da moltiplicarsi e interagire positivamente con il microbiota. Una caratteristica che dev’essere esplicitata in etichetta.
Probiotici e fermenti lattici sono sinonimi?
È un errore molto comune ritenere che siano la stessa cosa ma non è così. Lo spiegano anche gli esperti dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: «I fermenti lattici sono batteri in grado di produrre acido lattico partendo dalla fermentazione del lattosio, come la maggior parte dei probiotici, ma una volta ingeriti, non sopravvivono al passaggio nello stomaco». Quindi non è detto che i fermenti lattici di uno yogurt siano probiotici, cioè arrivino vivi fino all’intestino e siano in grado di esercitare un effetto benefico. Detto questo, qualsiasi yogurt bianco e al naturale resta un ottimo alimento perché i suoi fermenti lattici potrebbero comunque agire sul microbiota orale e fornire sostanze utili, cioè i metaboliti, di loro produzione (nell’ambito di una dieta varia e bilanciata).
Quando hanno indicazioni terapeutiche?
A giudicare dagli spot pubblicitari, i probiotici sembrano essere la panacea di tutti i mali, ma in realtà gli studi clinici attualmente disponibili restringono il loro raggio d’azione, limitandolo a specifici problemi di salute. Secondo le ultime linee guida della World Gastroenterology Organisation, ci sono prove scientifiche sufficienti perché il medico ne consigli l’uso in caso di:
• sindrome del colon irritabile;
• malattie infiammatorie intestinali come colite ulcerosa e morbo di Crohn;
• prevenzione e trattamento della diarrea acuta;
• prevenzione della diarrea associata a terapia antibiotica;
• prevenzione della diarrea causata dal batterio C. difficile;
• prevenzione della diarrea indotta da radioterapia;
• coliche nei lattanti;
• malassorbimento del lattosio;
• eradicazione dell’Helicobacter pylori in concomitanza con la terapia antibiotica specifica;
• steatosi epatica non alcolica (fegato grasso).
La ricerca procede a passo spedito e dagli studi clinici stanno emergendo nuovi indizi sull’utilità dei probiotici anche per altre condizioni come diabete, obesità, sindrome metabolica, ansia e depressione: sappiamo infatti che il microbiota intestinale influisce non solo sull’apparato digerente ma su tutto l’organismo, esercitando la sua azione anche su organi come il fegato e il cervello. È dunque possibile che in futuro aumenteranno le indicazioni all’uso dei probiotici man mano che le prove della loro efficacia diventeranno più convincenti.
Come scegliere per conto proprio un integratore o un prodotto del supermercato?
Ogni preparazione commerciale impiega ceppi differenti e non c’è la certezza che avrà un effetto benefico per l’individuo che l’assume, a meno che non si scelgano dei ceppi specifici per i quali ci siano dei dati a supporto di una particolare indicazione salutistica o di un effetto terapeutico ben preciso nel trattamento di una patologia, e in questi casi è preferibile che sia il medico a suggerire l’utilizzo di una terapia probiotica. Stando alle linee guida del ministero della Salute, «la quantità minima sufficiente di probiotici per ottenere una temporanea colonizzazione dell’intestino da parte di un ceppo microbico è di almeno un miliardo di cellule vive per giorno. La porzione di prodotto raccomandata per il consumo giornaliero deve quindi contenere una quantità pari a un miliardo di cellule vive per almeno uno dei ceppi presenti. L’uso di quantità inferiori può essere consentito solo se adeguati studi scientifici supportano comunque, per il ceppo in questione, la capacità di colonizzare a livello intestinale».
I prodotti commerciali possono essere dannosi?
I probiotici, usati da molto tempo, hanno mostrato di avere un profilo di sicurezza molto buono e davvero rarissimi effetti collaterali, se ne si considera l’ampio consumo nella popolazione generale. Tuttavia, in alcune categorie di soggetti fragili o immunodepressi il rischio di effetti collaterali invece c’è, per cui in quei casi è consigliabile consultare il proprio medico.
Che cosa leggere sull’etichetta?
Secondo un documento ufficiale (dell’International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, pubblicato nel 2014 su Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology), bisogna distinguere tra:
• probiotici (in alimenti o integratori) che in etichetta non riportano particolari benefici per la salute;
• probiotici che hanno un beneficio atteso per la salute, il cosiddetto health claim (per esempio, «favorisce l’equilibrio del microbiota»);
• probiotici che hanno un beneficio atteso per una condizione patologica specifica (con diciture come «indicato in caso di diarrea da rotavirus»), impiegati quasi alla stregua di un farmaco, anche se appartengono sempre alla categoria degli integratori e quindi la loro immissione sul mercato richiede studi clinici meno rigorosi.
Ogni ceppo ha delle caratteristiche che fanno sì che rientri in una di queste categorie. È importante quindi leggere che specie e che ceppo probiotico è contenuto nel prodotto e qual è la concentrazione di microrganismi vitali che viene assicurata dal produttore entro il termine della scadenza. Ovvio poi che si debba leggere la modalità di conservazione del prodotto.
Quali sono i più utilizzati?
I microrganismi possono avere origine alimentare oppure umana. «I più studiati e utilizzati sono i lattobacilli e i bifidobatteri, seguiti da bacilli Gram-negativi (come Escherichia coli Nissle) e Gram-positivi (per esempio, Bacillus clausii), cocci Gram-positivi (come Streptococcus thermophilus) e infine i lieviti (uno su tutti, Saccharomyces boulardii).
I probiotici colonizzano a lungo il microbiota?
Il concetto di colonizzazione resta molto dibattuto perché non è facilmente dimostrabile. Di certo sappiamo che i probiotici non perdurano nell’ecosistema intestinale quando si interrompe la loro assunzione: in genere dopo una o due settimane non sono più presenti nelle feci. Quello che rimane, però, è l’effetto benefico della loro azione, che può protrarsi nel tempo.
I probiotici possono agire attraverso diversi meccanismi (che variano in base alla specie e al ceppo):
• rinforzano la barriera intestinale;
• inibiscono la proliferazione dei microrganismi pericolosi;
• interagiscono con le cellule del sistema immunitario presenti nell’intestino regolandone l’attività.
Meglio in capsule, bustine solubili, flaconcini o gocce?
L’efficacia è la stessa, perché tutte le formulazioni usano tecnologie specifiche per garantire che quantità adeguate di microrganismi vivi arrivino nell’intestino: si può scegliere quella più adatta in base all’età e alle preferenze personali.
Prima o dopo i pasti?
La maggior parte degli studi clinici sono stati condotti somministrando i probiotici lontano dai pasti, in modo da ridurre i possibili effetti confondenti legati alla digestione del cibo, e questa indicazione è stata poi adottata anche nella pratica clinica. In genere si consiglia di assumere i probiotici a stomaco vuoto, ma nella maggioranza dei casi non ci sono evidenze che dimostrino che l’assunzione ai pasti possa comprometterne l’efficacia.
Gli integratori con quali bevande vanno assunti?
I probiotici sono microrganismi vivi, quindi sarebbe opportuno assumerli in modo da non alterare eccessivamente temperatura e pH. Si possono prendere con acqua naturale, latte o yogurt, mentre vanno evitate le bevande gasate e quelle calde.
Vanno presi periodicamente?
Contro la diarrea acuta, basta un ciclo di 5-7 giorni. Per la malattia diverticolare, il ciclo viene ripetuto a cadenza mensile o secondo le indicazioni del medico. In caso di disturbi cronici, come la sindrome del colon irritabile, i probiotici andrebbero assunti tutti i giorni per 8-12 settimane, ma per facilitare la vita dei pazienti spesso si prescrivono cicli più brevi ripetuti nel tempo a seconda della problematica.
Vanno assunti durante o dopo la terapia con antibiotici?
I probiotici vanno assunti durante la terapia antibiotica e possibilmente per una settimana dopo la fine della cura: bisogna però distanziarli di alcune ore dall’assunzione del farmaco. Se, per esempio, si prende l’antibiotico al mattino e alla sera, il probiotico può essere assunto a metà pomeriggio.
Quando si prendono i probiotici bisogna modificare l’alimentazione?
Non ci sono particolari raccomandazioni, se non quella di seguire come sempre una dieta varia e ricca di frutta e verdura fresche, legumi e frutta secca: le fibre vegetali vanno infatti a nutrire i probiotici rafforzando la loro azione.
Possono esserci interazioni con altri farmaci, integratori o fitoterapici?
In genere non ci sono problemi, ma è meglio chiedere consiglio al proprio medico o al farmacista, perché alcuni prodotti probiotici possono contenere anche vitamine e altri principi attivi.
Possono interferire con gli esami di laboratorio?
Sebbene i probiotici finiscano nelle feci, non interferiscono con gli esami colturali perché sono altri i batteri che vengono ricercati attraverso le analisi. Bisogna invece sospenderli almeno due settimane prima di sottoporsi a esami come il breath test (test del respiro) per l’intolleranza al lattosio o la ricerca dell’Helicobacter pylori, perché i probiotici possono produrre sostanze che alterano i risultati.
Possono causare effetti collaterali?
I probiotici derivano da alimenti fermentati o da microrganismi presenti nell’intestino umano sano: il loro utilizzo ormai decennale non ha evidenziato particolari rischi per la salute. Si raccomanda solo maggiore cautela nelle persone immunodepresse, che dovrebbero assumerli sotto controllo medico. A volte possono essere associati a effetti collaterali minori e transitori come l’aumento del gonfiore intestinale.