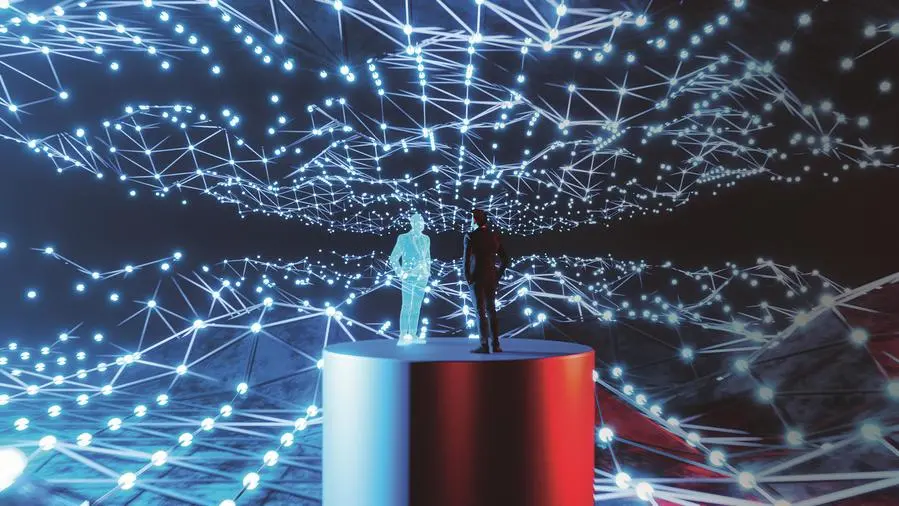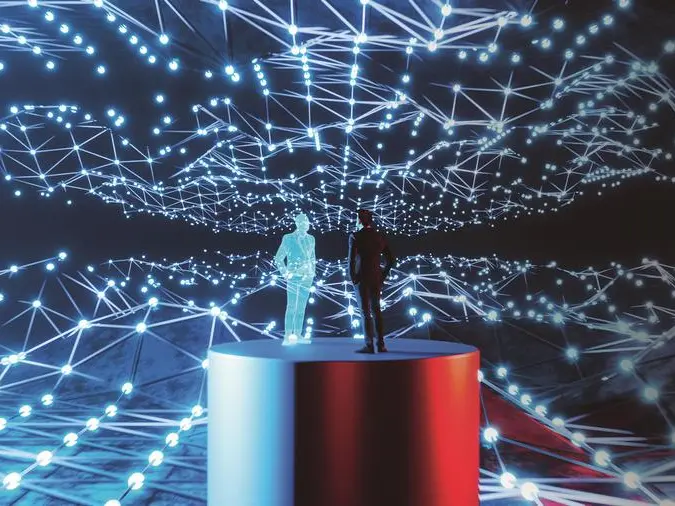PHOTO
Pierluigi Paracchi, amministratore delegato di Genenta Science, società che ha fondato nel 2014 insieme a Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia genica
La frontiera della lotta al cancro sembra fantascienza. In parole semplici, si arma il sistema immunitario del paziente perché siano le sue stesse difese a sconfiggere il tumore. Come si fa? Aggiungendo un gene nelle cellule in modo che diventino fabbriche viventi di proiettili molecolari in grado di colpire il tumore in maniera mirata. La sperimentazione clinica, già su pazienti, è in fase avanzata.
L’opportunità, per i malati, è di quelle che accendono le speranze: agire su alcuni tumori in fase avanzata o metastatica con una terapia non invasiva e più mirata di quelle tradizionali utilizzate fino a oggi.
Dietro tutto questo c’è una realtà di pregio: Genenta Science, unica biotech italiana a essere quotata al Nasdaq di New York (dal 2021), la borsa dei titoli hi tech. Per intendersi, quella dove sono quotate Apple, Amazon e Google. È una ex start up, come sono definite le nuove imprese tecnologiche.


Paracchi e il suo team appaiono in foto al Nasdaq di New York, dov’è quotata Genenta Science dal 2021.
La ricerca è iniziata più di vent’anni fa, nei laboratori dell’ospedale San Raffaele di Milano. Appariva avveniristica, ma gli scienziati e gli investitori non hanno mai smesso di credervi. E ora c’è una terapia già in fase clinica di sviluppo. Si tratta di una cura tutta made in Italy e destinata, se i risultati dei test saranno confermati, a far compiere un notevole passo avanti alla cura di alcune delle forme di cancro più gravi. Per la precisione dei tumori solidi avanzati (cioè non del sangue o del sistema linfatico).
Nella ricerca sulle terapie geniche l'Italia è ai massimi livelli, ma studi e sperimentazioni costano e comportano rischi economici. Dove non arrivano le risorse pubbliche, arrivano i privati, ovviamente con la prospettiva di ripagare i costi e ricavarne un profitto. In questo caso a mettere insieme le due cose, la scienza e le risorse per finanziarla, è stato Pierluigi Paracchi, laurea in Economia alla Cattolica e una carriera tra banche internazionali, fondi d’investimento e start up in ambito tecnologico. È amministratore delegato e co-fondatore della società insieme a Luigi Naldini, che presiede il Comitato scientifico, figura di spicco della ricerca e direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia genica.
Pierluigi Paracchi, proviamo a spiegare, anche ai non addetti ai lavori, le prospettive della nuova terapia genica e cellulare. Il punto di partenza sono le staminali, cioè le cellule primitive, non ancora specializzate.
«Noi preleviamo dal midollo osseo del paziente le staminali del sistema immunitario, cioè quelle che danno origine ai globuli bianchi. Poi le ingegnerizziamo: vuol dire che le modifichiamo geneticamente per renderle capaci di combattere meglio la malattia».
Che modifica genica apportate?
«Dotiamo le staminali di un gene che ordina la produzione di una proteina con un’azione antitumorale molto potente, l’interferone alfa».
Si sa da tempo che l’interferone alfa è una proteina con proprietà antitumorali.
«È vero, ma il problema è sempre stato che, per funzionare bene, servivano dosi così alte da provocare effetti collaterali sistemici. In altre parole, la proteina non agiva solo sul tumore ma anche sui tessuti sani, e questo ne limitava molto l’uso».
E voi che cosa avete fatto?
«La nostra tecnologia fa sì che le cellule modificate producano interferone alfa solo dove serve, in maniera mirata, appunto: nel microambiente del tumore. I globuli bianchi “istruiti” con la terapia genica diventano capaci di infiltrarsi nel tumore e di agire localmente. Così aumenta l’efficacia dell’interferone e si riduce il rischio che vengano danneggiati organi sani».
Quindi è il malato che si cura da solo…
«Il sistema immunitario del paziente stesso viene “addestrato” a lavorare all’interno del tumore, risparmiando gli altri tessuti».
Le staminali restano modificate nel tempo?
«Esatto, si crea una sorta di autovaccinazione. Le staminali del sistema immunitario del paziente dovrebbero continuare a dare origine a globuli bianchi con questo interferone alfa. Per capirci: se dovesse partire una metastasi, il sistema immunitario sarebbe già strutturato per attaccarla».
A livello internazionale ci sono altre ricerche di questo tipo in corso?
«Il nostro approccio sulle staminali è una strada completamente nuova, siamo i soli ad averla testata. Abbiamo un pacchetto di brevetti che nasce dall'attività di ricerca iniziata nei laboratori del San Raffaele. L’ospedale li ha poi conferiti a Genenta, di cui è diventato socio. È un lavoro tutto italiano e i primi pazienti curati sono italiani».
Voi state sviluppando un farmaco, come si legge nel vostro sito, ma non è una molecola che si assume per via orale o endovenosa.
«Proprio così. Si definisce “farmaco” anche la nostra terapia genica e cellulare. Ha il nome di Temferon».
Veniamo ai risultati clinici.
«La sperimentazione è iniziata sul glioblastoma, che è la forma più aggressiva di cancro al cervello. Per questo tumore, le terapie disponibili attualmente possono solo ritardare la progressione della malattia, che però resta molto rapida. I nostri primi risultati clinici sono incoraggianti. Il numero di pazienti trattati non è ancora abbastanza alto da fare statistica, ma il tasso di sopravvivenza medio a due anni è al 29%, contro il 14% delle altre terapie».
Quali altri tumori si potranno curare?
«Abbiamo studi preclinici, che sono stati pubblicati sulle maggiori riviste scientifiche e che riguardano il cancro al seno, al colon e al fegato. Dalla fine dell’anno scorso abbiamo iniziato a trattare anche il tumore al rene metastatico e stiamo reclutando pazienti».
Come si reclutano i pazienti per gli studi?
«Noi abbiamo avuto il permesso dell’Aifa, che ha valutato la sicurezza del nostro protocollo. Poi abbiamo coinvolto una rete di centri clinici specializzati: lì i medici valutano se i pazienti hanno i requisiti per partecipare alla sperimentazione, in base alle loro condizioni di salute, al tipo di tumore e alle terapie già fatte. Chi rientra nei criteri viene informato in modo chiaro sui possibili benefici e rischi, e può decidere liberamente se partecipare o no».
Come vede il futuro?
«La strada è aperta, è una tecnologia che ha potenzialmente impieghi molto vasti».