PHOTO
Gabriella Pravettoni, direttrice della divisione di Psiconcologia dello Ieo-Istituto europeo di oncologia di Milano (foto di Manuel Cicchetti)
Una fitta allo stomaco, poi la nausea, il cuore che sussulta, la testa che gira e l’impressione di essere catapultati in un incubo. All’improvviso, davanti agli occhi scorrono nitide le prime sequenze di un nuovo film: quello della vita che cambierà a causa della malattia, evidenziando una linea netta di demarcazione fra il tempo di prima e quello che c’è adesso. Proprio a questo tempo prezioso è dedicato l’ultimo libro di Gabriella Pravettoni, docente ordinaria di Psicologia delle decisioni all’Università degli Studi di Milano e direttrice della divisione di Psiconcologia dello Ieo-Istituto europeo di oncologia, sempre nel capoluogo lombardo. Scritto con il giornalista Mauro Boldrini, La vita è adesso (Cairo) vuole indicare, tra ricerche scientifiche e testimonianze reali, una via che possa accendere nei pazienti la luce della speranza. Una medicina potente.
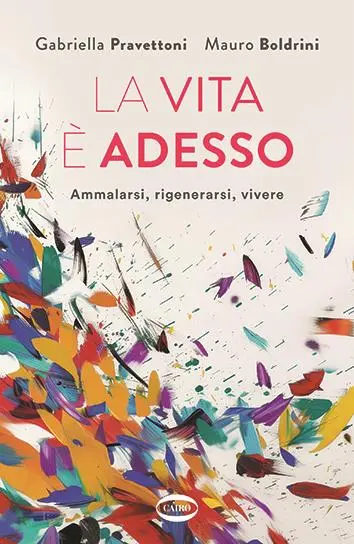
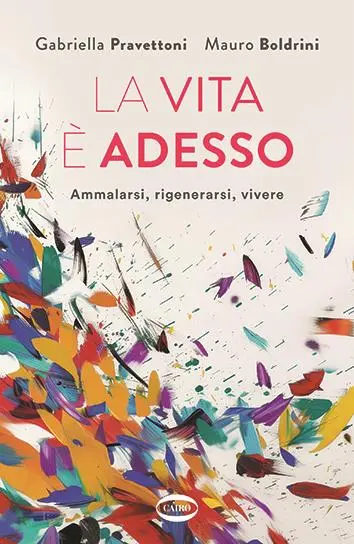
Il libro La vita è adesso (Cairo), firmato da Gabriella Pravettoni e da Mauro Boldrini, giornalista scientifico e direttore della comunicazione dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom).
Professoressa Pravettoni, lei parte da un dato: la diagnosi di tumore è traumatica.
«Sì, è come una deflagrazione imprevista che coinvolge ogni aspetto della vita, fisica ed emotiva. La comunicazione della malattia è un momento destabilizzante sia per il paziente sia per i suoi familiari: è un trauma che rompe gli equilibri precedenti e, simile a uno tsunami, spazza via le certezze e i progetti del “prima” spostando l’attenzione su un “dopo” tutto da costruire, che spesso genera incertezza, panico e paura».
Questo trauma ha un impatto sulla salute psichica?
«Oggi si stima che il 20% dei malati oncologici sia colpito da depressione, il 10% da ansia e che oltre il 50% sviluppi dei disagi psicologici, che hanno notevoli ricadute sull’efficacia dei sistemi di difesa».
Quindi sul sistema immunitario e sulla possibilità di guarigione?
«Uno studio pubblicato su Nature Reviews Cancer ha evidenziato come lo stress cronico, legato alla paura della malattia, sia in grado di influenzare la progressione del cancro attraverso la sovraproduzione di adrenalina e cortisolo: questi ormoni possono promuovere la crescita neoplastica agendo sul microambiente del tumore, aumentando l’infiammazione e la vascolarizzazione, e sopprimendo la risposta immunitaria del corpo».
Vari altri studi confermano il legame tra stress e cancro…
«In un articolo uscito su Nature si legge che le cellule del carcinoma mammario tendono a creare metastasi più velocemente quando si accerta una presenza rilevante di ormoni dello stress. E un’altra ricerca presentata su The Lancet Oncology ha rilevato che la depressione tende a ridurre la sopravvivenza nei malati di tumore, suggerendo quindi che i disturbi emotivi possono avere un’influenza negativa sul decorso della malattia. Tutte queste evidenze confermano che il legame fra cancro e psiche è molto stretto».
L’atteggiamento emotivo del paziente può fare la differenza?
«Sì, anche in termini di adesione ai protocolli di cura e di successo delle terapie. Non a caso anche in Italia nelle breast unit, cioè le unità multidisciplinari degli ospedali dedicate al tumore al seno, è obbligatoria la presenza di uno psiconcologo, di un professionista specializzato».
Meglio dire tutto o lasciare qualche zona d’ombra?
«Non si può generalizzare, perché ogni caso di cancro è una storia a sé. Di regola, non bisogna mai illudere il paziente, che ha diritto di sapere ma anche di non sapere. Nella fase della diagnosi, la persona va prima di tutto accolta con empatia, facendo in modo che si senta protetta e accudita di fronte alla prospettiva del viaggio, talvolta lungo e impegnativo, che dovrà affrontare. In seguito, si potranno fornire spiegazioni più specifiche ma sempre in maniera personalizzata, tenendo conto delle sue competenze, del suo desiderio di conoscere ma anche delle sue fragilità e della sua capacità di reggere o meno lo stress».
Il supporto psicologico favorisce la guarigione?
«È più corretto dire che influisce sul benessere e sulla qualità della vita del paziente. Ormai è stato sufficientemente dimostrato che quando si sta bene il corpo libera endorfine, che contribuiscono a sostenere la risposta immunitaria, ma questo non significa che i pensieri positivi possano sostituire le cure oncologiche».
Umberto Veronesi era solito affermare che l’oncologo dovrebbe essere anche uno psicologo.
«La diagnosi non va mai scaricata addosso al paziente, ma dev’essere illustrata con rispetto e delicatezza».
Non accade sempre così…
«Purtroppo no. Va detto che l’oncologo vive quotidianamente immerso nella sofferenza e nel dolore, con un rischio di burnout altissimo, che in certi casi potrebbe determinare un certo distacco nelle comunicazioni con i malati. Ecco perché la presenza di uno psiconcologo negli ospedali, come pure l’assistenza che oggi si può fornire da remoto, sono fondamentali per aiutare sia il paziente che il personale sanitario».
In Francia negli ospedali vige l’obbligo di presenza di uno psicologo accanto al medico durante la condivisione degli esiti degli esami, a maggior ragione quando si tratta di patologie oncologiche. Da noi?
«Lo psiconcologo svolge un’essenziale funzione di primo soccorso in caso di reazioni emotive importanti conseguenti allo choc della diagnosi ma anche in seguito, per valutare il livello del disagio nel corso delle terapie. In Italia la sua presenza non è prevista al momento della diagnosi. Ma il problema è che in metà dei centri oncologici manca del tutto la figura».
Da noi quanti pazienti ricevono il supporto psicologico?
«Sulla carta, è prevista la presenza dello psiconcologo in circa la metà dei centri specializzati in cure per il cancro, ma in realtà solo il 20% dei pazienti riceve questo supporto».
Secondi i dati diffusi nel 2024 da Soleterre, fondazione che opera per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute, da noi la media è di 2,2 psicologi (negli ospedali pubblici) ogni 100mila abitanti.
«Il numero di professionisti presenti nel Sistema sanitario nazionale è ben distante dall’obiettivo di avere uno psicologo ogni 1.500 abitanti, come indicato dagli studi di settore».
Soleterre sottolinea anche che da noi la maggioranza dei servizi psiconcologici viene tuttora affidata a precari o a borsisti finanziati da enti del terzo settore: per esempio, su 82 psicologi presenti nelle oncologie pediatriche, solo il 28% ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
«È una situazione che incide negativamente sul lavoro dei sanitari e sulla qualità della vita dei pazienti, e lascia intendere che, nel nostro Paese, il sostegno psicologico è ancora percepito come un lusso più che come una necessità».
Nel resto d’Europa?
«Posso dire che in Europa soltanto il 37% dei Paesi prevede investimenti specifici in una formazione specifica in psiconcologia, per evitare che lo psicologo “generalista” si debba dividere su più reparti spesso molto diversi fra loro, e senza mai poter fornire, di fatto, un aiuto davvero mirato».
Di preciso in che modo è d’aiuto lo psiconcologo?
«Lo psiconcologo identifica e lavora in maniera personalizzata sui disagi che si manifestano dopo una diagnosi di cancro, perché le reazioni, in effetti, possono essere molto diverse: c’è chi non nomina la malattia e chi invece ne parla e desidera condividere il proprio stato con coloro che magari hanno già affrontato lo stesso problema, alcuni si isolano e tagliano i ponti col mondo, altri non versano una lacrima e non esternano la paura, altri ancora non accettano la diagnosi e oscillano fra senso di resa e rabbia violenta. Ogni situazione merita un trattamento su misura».
Anche i familiari devono essere coinvolti e sostenuti?
«Il tumore una malattia familiare per definizione, e genera altissimi livelli di stress che si riverberano sulla cerchia degli affetti del paziente. Pensiamo alle giovani madri che si ammalano e temono di dover lasciare bambini ancora piccoli, alle donne che per curarsi sono costrette a rinunciare alla maternità, ai genitori ormai anziani che non accettano il tumore del figlio… Nessuno dev’essere lasciato solo».
Che cosa bisogna spiegare?
«Che la malata o il malato restano prima di tutto una persona e non vanno mai identificati con la patologia: indipendentemente dalla prognosi, la vita è adesso e non si può sprecarne nemmeno un minuto, anche durante le cure. Ed è essenziale che sia una vita di qualità».
Quale aiuto si può fornire alla coppia?
«La diagnosi di tumore implica una nuova gestione della sessualità perché la sensazione di “non essere più gli stessi” a seguito della malattia si riflette anche nella sfera intima: ci si può sentire meno attraenti o desiderabili, e questo può generare una distanza fisica ed emotiva con il partner. I percorsi di sostegno saranno individuali e da definire in base all’età e alle esigenze della coppia, come accade per esempio quando si stava programmando una maternità e la donna deve seguire terapie che inducono la menopausa o, nel caso dell’uomo, quando i farmaci provocano calo della libido e disturbi erettili».
È utile tornare al lavoro dopo la diagnosi?
«Ci sono persone che in ufficio impegnano il cervello, parlano della malattia con i colleghi e allontanano, sia pure per qualche ora, il pensiero del tumore, e altre per le quali una pausa dal contesto lavorativo può essere salutare e terapeutica: ancora una volta, dipende dal paziente. In ogni caso, era sempre Umberto Veronesi a sottolineare che il vero obiettivo della cura oncologica è quello di eliminare la malattia non soltanto dal corpo e dai tessuti, ma anche dalla mente: tutto ciò che aiuta in tal senso è sicuramente positivo».
Come si parla di futuro al paziente oncologico?
«La diagnosi di tumore interrompe il delirio d’immortalità tipico della società contemporanea e ci riporta con i piedi per terra, rimescolando le carte dell’esistenza. Ai pazienti oncologici dico che oggi, grazie a diagnosi precoci, medicina di precisione, immunoterapia e alle nuove frontiere di ricerca aperte dall’IA, è davvero possibile raggiungere la guarigione o cronicizzare il cancro. È grazie a queste prospettive che ciascuno ha il diritto di guardare oltre la malattia e dentro la vita. Perché il tumore è solo una parte della storia, ma non l’unica».









