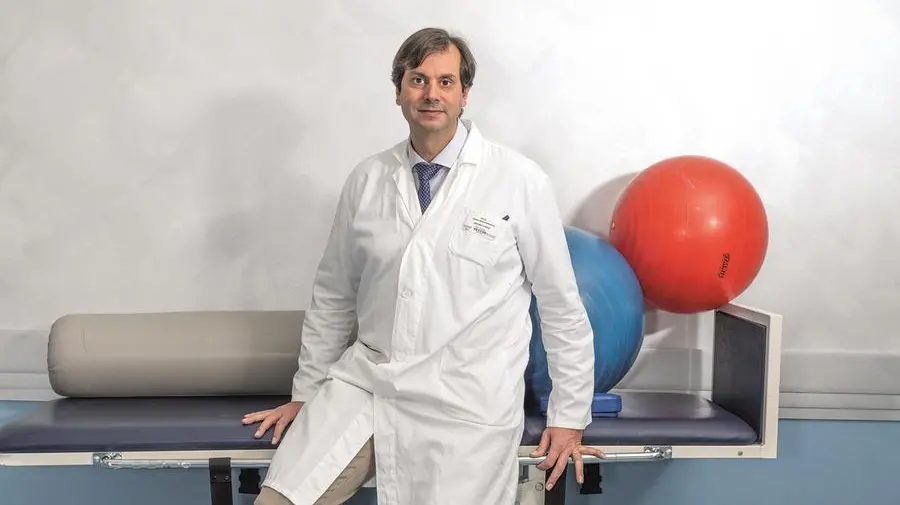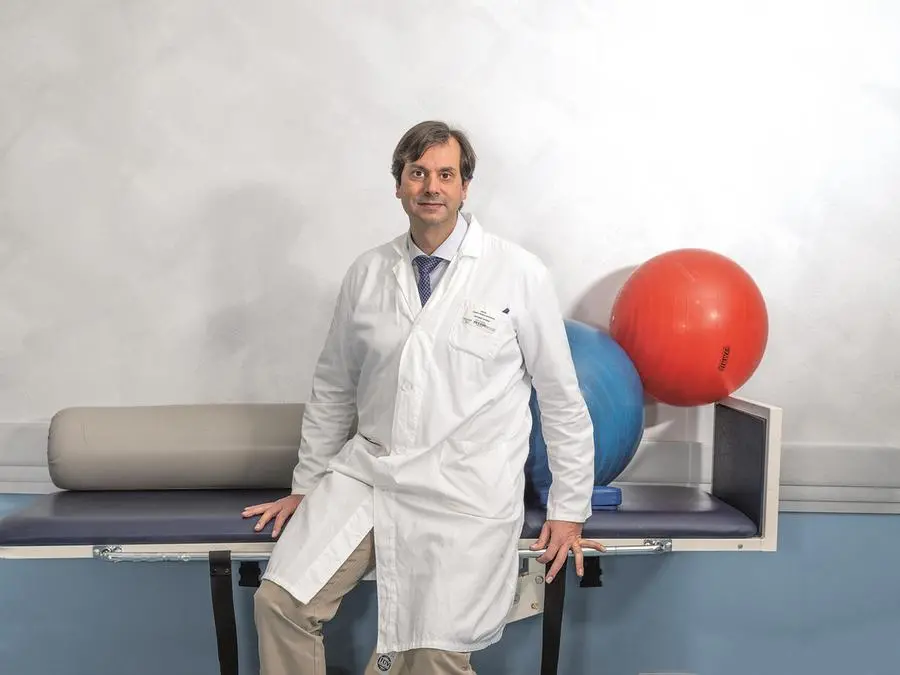PHOTO
Maria Assunta Gabrielli, direttrice del Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi di Firenze (foto di Simone Donati)
Quanto è grande l’universo? Più o meno, dieci metri quadrati. Misura così la stanza multisensoriale del Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi di Firenze, dove i bambini con gravi disabilità fisiche e psichiche possono trovare un microcosmo costruito su misura per loro.
I piccoli pazienti, dai tre mesi in su, vengono stimolati con fasci di fibre ottiche, colonne di bolle luminose, pouf imbottiti, amache, pedane vibranti, immagini proiettate sui muri, suoni che provengono da casse acustiche nascoste sotto varie superfici di appoggio. Grazie a questi ritrovati della ricerca e dell’innovazione tecnologica, i bambini allenano i loro cinque sensi in un’atmosfera rilassante, che ha come sottofondo i suoni della natura. Nelle sedute, che durano circa 45 minuti, viene coinvolta anche la famiglia con l’obiettivo di favorire la relazione e la comunicazione tra genitori e figli.
Il reparto di riabilitazione pediatrica, nato in collaborazione con l’ospedale Meyer di Firenze e la Fondazione Tommasino Bacciotti, assiste oltre cento bambini all’anno affetti da malattie neurologiche complesse con difficoltà di tipo motorio, respiratorio, cognitivo, del linguaggio e della deglutizione. Patologie che insorgono a seguito di traumi cranici, tumori cerebrali, ictus, meningiti, encefaliti, con possibile compromissione dello stato di coscienza. «Il nostro reparto di riabilitazione pediatrica è quasi un unicum nel suo genere, con pochi precedenti in Italia», tiene a sottolineare Maria Assunta Gabrielli, neodirettrice del Centro Don Gnocchi fiorentino.
La tecnologia è una grande alleata. Per esempio, una cuffia applicata sulla testa effettua stimolazioni elettriche transcraniche (non invasive) nelle aree del cervello con una residua attività, allo scopo di potenziarle. E c’è una novità: dal 26 marzo è attivo il CARE-Lab, un laboratorio di realtà semi-immersiva.
Dottoressa Gabrielli, perché la realtà virtuale aiuta i bimbi con deficit neuromotori e cognitivi?
«Nella stanza ad alta tecnologia del CARE-Lab, attrezzata con strumentazioni audio e video, i piccoli pazienti possono svolgere attività di riabilitazione motoria e cognitiva in maniera interattiva: le pareti della stanza si trasformano in un parco giochi molto colorato e, muovendo mani o piedi, i bambini devono spostare oggetti virtuali, catturare scimmiette, abbinare immagini».
Come si valutano i progressi?
«Le attività svolte dai bambini vengono rilevate tramite sensori e videocamere, ma anche osservate attraverso specchi unidirezionali, un po’ come quelli che vediamo nelle stanze degli interrogatori nei film polizieschi in tv. Elaborando le varie informazioni, i terapeuti possono monitorare il percorso riabilitativo, personalizzando e adattando le attività ludiche a ogni sessione».


Un'immagine del CARE-Lab, laboratorio di realtà semi-immersiva per i piccoli pazienti del Centro Don Gnocchi di Firenze (foto di Simone Donati)
Quindi, rispetto ad altri ambiti di cura dove i trattamenti sono standardizzati, per voi conta molto l’individualità del malato.
«Assolutamente sì, è la nostra missione. Oltre a fornire un’assistenza di alta qualità, ci ispiriamo ogni giorno al nostro fondatore, don Carlo Gnocchi, che nel 1954 scriveva: “Non esistono malattie, ma malati, cioè un dato modo di ammalarsi proprio di ciascuno e corrispondente alla sua profonda individualità somatica, umorale e psicologica”. Questo significa curare le persone con empatia, tenere conto della loro unicità, coinvolgere le famiglie con tutti i loro vissuti».
Vale anche per i pazienti adulti?
«Certo. Fra i tanti servizi, ne offriamo uno di analisi del movimento e del cammino, rivolto prevalentemente a persone affette da patologie neurologiche quali disordini del movimento, malattia di Parkinson, parkinsonismi, sclerosi multipla, esiti di ictus, neuropatie, traumi cranici e midollari. Studiando la singola persona e analizzando il suo schema del passo, è possibile avviare progetti riabilitativi specifici con l’ausilio di tutori su misura che correggono la deambulazione, fornendo maggiore confidenza, sicurezza e autonomia».


Il Centro di riabilitazione Don Carlo Gnocchi di Firenze è dotato di strumentazioni avanzate, tra cui diverse tecnologie robotiche, che possono supportare il recupero dei pazienti (foto di Simone Donati)
Anche gli spazi sono strutturati in maniera più inclusiva, vero?
«Sì, abbiamo posizionato la palestra all’interno del reparto di degenza. Questo evita ai pazienti di vivere la riabilitazione come un momento a sé e permette uno scambio continuo con infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, neuropsicologi, psicologi e altri specialisti».
Fra i tanti, c’è un paziente che ricorda in particolare?
«Mi ritorna alla mente Marco (nome di fantasia), 78 anni, che era stato ricoverato presso il nostro centro dopo aver subito un ictus ischemico. Al momento dell’ingresso, presentava una paralisi del lato sinistro del corpo, difficoltà nel linguaggio e un lieve deficit di attenzione. La sua condizione rappresentava una sfida significativa non soltanto per lui, ma anche per la famiglia. Durante il percorso riabilitativo, Marco ha gradualmente ripreso la capacità di alzare il braccio e compiere movimenti più complessi, come afferrare oggetti e portare un bicchiere alla bocca, ma il recupero della mano restava l’aspetto più difficile».
Come siete intervenuti?
«Abbiamo sfruttato una serie di tecnologie avanzate, tra cui il robot riabilitativo che integra e supporta il lavoro dei terapisti nella riabilitazione dell’arto superiore con un’azione specifica sui movimenti di mano, polso, gomito e spalla. Grazie a sessioni quotidiane di giochi interattivi sempre più difficili e complessi, Marco ha recuperato la mobilità dell’arto superiore. Parallelamente, ha seguito una riabilitazione per i disturbi del linguaggio, utilizzando software specializzati e un tablet con esercizi mirati che gli hanno consentito di esercitare la capacità di esprimersi in un ambiente stimolante e coinvolgente. Così ha ripreso a pronunciare parole e frasi, ripristinando la comunicazione con il team di logopedia e con la sua famiglia, composta da moglie e figli».
E sul fronte della diagnostica?
«Il nostro centro è all’avanguardia. Quest’anno abbiamo ampliato il servizio di radiologia con la tomografia assiale computerizzata, ma ci sono capisaldi di grande interesse. Per esempio, disponiamo di strumenti di ultima generazione per effettuare la diagnosi dei disturbi del sonno».
Quali disturbi del sonno diagnosticate? Anche il russamento?
«Sì, il russamento abituale o le apnee notturne. Una procedura avanzata combina la polisonnografia con l’elettroencefalogramma ad alta densità, quest’ultimo registrato con un elevato numero di elettrodi per identificare e studiare le onde cerebrali, i movimenti oculari, il tono muscolare durante i diversi stadi del sonno, oltre al flusso del respiro e al livello di ossigeno. Non a caso, siamo stati accreditati dall’Accademia italiana di medicina del sonno come centro di riferimento per il settore».
Collaborate anche con l’Università di Firenze?
«Il nostro centro è sede della Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa dell’Università degli studi di Firenze, oltre che luogo di tirocini per molte professioni sanitarie. Le collaborazioni con le istituzioni del territorio sono un valore aggiunto. Oltre al Meyer, lavoriamo anche con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e questo ci consente di offrire percorsi riabilitativi di alta qualità, sfruttando le competenze multidisciplinari».
A proposito di professioni di cura, quella è una passione di famiglia nel suo caso…
«In effetti, sì. Ho tre figlie, Irene, Ilaria e Laura, rispettivamente di 36, 33 e 30 anni. Irene è una terapista occupazionale della Fondazione Don Gnocchi, Ilaria è una psicologa psicoterapeuta che lavora nell’Hospice di Marina di Massa e presso la Casa di Reclusione di Massa, Laura insegna a Firenze in una scuola primaria. Sin da piccole hanno dimostrato grande interesse per il mondo della disabilità, impegnandosi in prima persona nel volontariato».
Lei è direttrice di una struttura importante. In Italia, ancora oggi, non è scontato che una donna arrivi a posizioni apicali.
«Essere direttrice di un Istituto di ricerca, ed esserlo da donna, è una grande conquista e ripaga di tanti sacrifici che non sono mancati, dei pregiudizi, delle difficoltà nel percorso lavorativo. Credo di essere una persona determinata, competente nel mio ambito e soprattutto sostenuta da una grande fede. Queste tre caratteristiche hanno giocato a mio favore nel percorso che ho realizzato. Lo scrittore americano Richard Bach ha detto: “Quanto più mi piace fare qualcosa, tanto meno lo chiamo lavoro”. Vale anche per me».