PHOTO
Come si prendono le decisioni nel quotidiano? Iniziamo con una domanda a cui ti invitiamo a rispondere in velocità. «Una racchetta da ping pong e una pallina costano, sommate insieme, un euro e dieci centesimi. La racchetta costa un euro in più della pallina: quanto costa la pallina?».
Quel che accade è che molto probabilmente giunge alla tua mente una risposta prepotente e veloce, che risulta però errata a una più attenta riflessione... Il motivo è spiegato, secondo Daniel Kahneman (psicologo e premio Nobel per l’economia nel 2002), dall’esistenza di due sistemi di ragionamento che presentano delle differenze significative.
• Il Sistema 1 è basato sulla percezione diretta, è veloce e automatico. Viene attivato con l’intuizione e ha il compito di produrre subito delle soluzioni da usare nei compiti che svolgiamo nel quotidiano (dal camminare al pettinarsi). Associa le nuove informazioni a schemi già presenti.
• Il Sistema 2 invece è più lento, deliberativo e logico. Richiede uno sforzo maggiore, consapevole, e vi ricorriamo quando dobbiamo affrontare compiti complessi.
Ogni sistema di pensiero ha la propria funzione: mentre il Sistema 1 tiene conto delle percezioni dell’ambiente e della memoria visiva e associativa, il Sistema 2 ha il compito di produrre conclusioni basate sulle intuizioni del primo sistema. I due sistemi sono continuamente attivi e in comunicazione, tuttavia uno domina sempre sull’altro a seconda dell’attività che stiamo realizzando.
Il Sistema 1 si prende carico dei problemi così come essi vengono presentati e tenta subito una soluzione. Il Sistema 2 convalida, corregge o cestina queste soluzioni, spesso riformula il problema ma lo fa solo se viene chiamato a farlo. Quando non viene mobilitato, si usa la soluzione offerta dal Sistema 1. In particolare, si ha la sostituzione di attributi quando il Sistema 1 subentra, a nostra insaputa, e non attende una convalida dal Sistema 2.
Ed ecco la possibile risoluzione della domanda iniziale: dieci centesimi. La maggioranza risponde così, ma la risposta è errata ed è facile verificarlo: se la pallina costasse dieci centesimi, la racchetta costerebbe un euro e dieci centesimi e quindi non potrebbero insieme costare un euro e dieci centesimi! La risposta esatta è: cinque centesimi.
Quello che ci suggerisce il Sistema 1 (dieci centesimi) ci pare però così persuasivo che non facciamo intervenire il Sistema 2. Di fronte alle scelte quotidiane, quindi, il nostro approccio può essere definito euristico, ovvero seguiamo un percorso di pensieri che fa uso di molte scorciatoie mentali per permetterci di formulare giudizi in pochissimo tempo, definiti bias. (…)
Distorsioni e preconcetti
I bias cognitivi, attraverso le loro distorsioni sistematiche, non solo influenzano il modo in cui interpretiamo la realtà, ma forniscono anche le basi per la formazione e il consolidamento dei pregiudizi, che rappresentano giudizi precostituiti e generalizzazioni spesso applicate al contesto sociale e interpersonale. Il termine pregiudizio deriva dal latino praeiudicium, composto di prae, “prima”, e iudicium, “giudizio”, e potrebbe essere definito come un “giudizio anticipato”, formulato cioè prima della conoscenza diretta e approfondita di una situazione, un problema o una persona.
I pregiudizi possono formarsi attraverso una serie di processi psicologici complessi, che spesso operano in modo sottile nelle nostre menti, al di sotto della nostra soglia di consapevolezza. (…)
Anche i pregiudizi nascono con la “buona intenzione” di facilitare l’elaborazione delle informazioni o il prendere una decisione, ma anch’essi possono portare a errori e distorsioni. Bias e pregiudizi si rafforzano a vicenda in un ciclo continuo. (…)
Nella pratica quotidiana
Nella comprensione della comunicazione interpersonale, tutti i concetti presentati hanno un impatto particolarmente rilevante, perché mostrano il modo in cui percepiamo, interpretiamo e rispondiamo agli altri durante le relazioni.
• Attribuzione disposizionale: quando comunichiamo, tendiamo spesso a giudicare le azioni degli altri attribuendole a caratteristiche personali (per esempio: «È scortese»), ignorando fattori contestuali (per esempio: «Ha avuto una giornata difficile»).
• Percezione selettiva: influenza ciò che notiamo nelle interazioni, tende a rafforzare pregiudizi preesistenti e può limitarci nella comprensione completa di un messaggio. Durante una discussione, possiamo notare, per esempio, solo il tono irritato dell’altra persona, ignorando il contenuto valido di ciò che sta dicendo.
• Bias di conferma: nelle conversazioni, tendiamo a cercare elementi che confermino le nostre opinioni e ignoriamo ciò che le contraddice. Questo bias ostacola un ascolto aperto e può bloccare la risoluzione dei conflitti.
I pregiudizi alterano il modo in cui interpretiamo i messaggi, portandoci a vedere ciò che conferma le nostre aspettative, ignorando o reinterpretando informazioni contrarie. Quando un pregiudizio è presente, tendiamo a non ascoltare davvero il messaggio dell’altro, filtrando ciò che non si allinea con le nostre convinzioni.
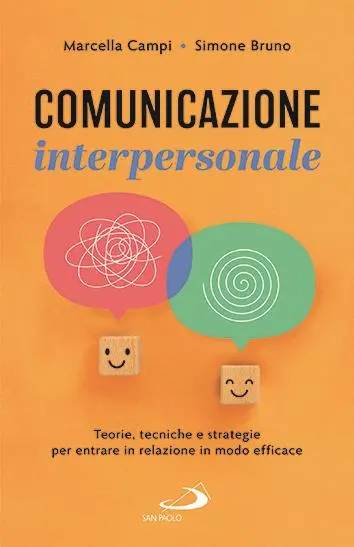
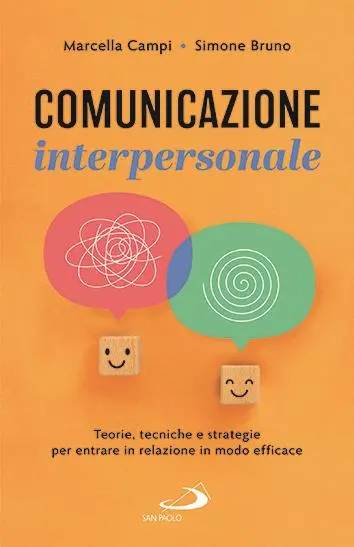
Il testo è tratto dal saggio Comunicazione interpersonale - Teorie, tecniche e strategie per entrare in relazione in modo efficace (Edizioni San Paolo). Gli autori sono due psicologi e psicoterapeuti: Marcella Campi e Simone Bruno, direttore editoriale delle Edizioni San Paolo. Il loro libro riprende i capisaldi teorici classici della comunicazione umana e li amplia con le nuove frontiere degli studi neuroscientifici e linguistici, ma propone anche una parte pratica: i lettori potranno cimentarsi con attività per tutti i giorni.











