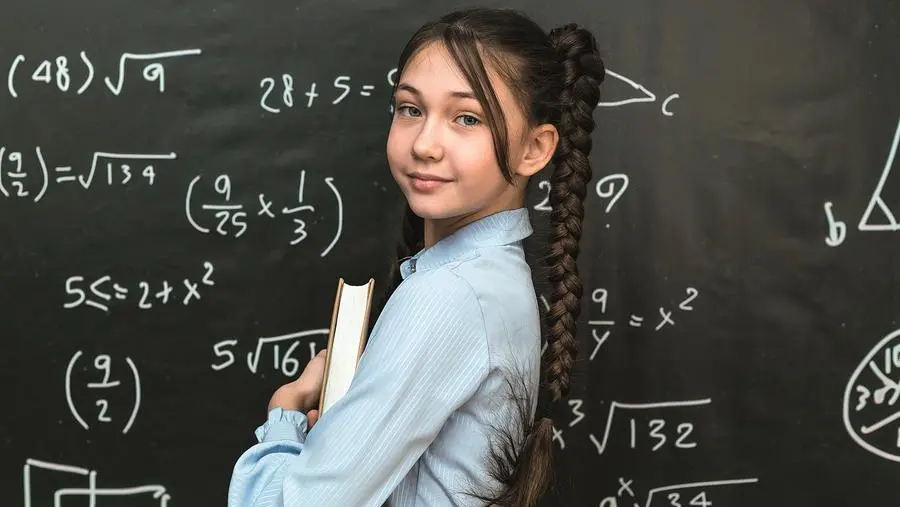PHOTO
Daniela Chieffo è la dirigente responsabile dell’unità operativa semplice di Psicologia clinica alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. Dal 2022 è anche a capo del progetto a sostegno della salute mentale dei ragazzi #Withyou – La psicologia con te, sviluppato dal Comitato Italiano per l’Unicef insieme alla Fondazione Policlinico universitario Gemelli.
Tre quarti degli studenti italiani dichiara di avere “sempre” o “spesso” episodi di stress causati dalla scuola. Il 44% si sente inadeguato e insicuro per un eccesso di competitività in classe. Numeri altissimi, che emergono da un sondaggio su oltre 25.500 alunni delle superiori (collegati l’anno scorso all’evento “Scuola e benessere: oltre l’ipercompetizione e l’omologazione”, nato dalla collaborazione tra Unisona Live e Unicef).
È cambiato qualcosa rispetto al passato? Ha influito la lunga parentesi di isolamento durante il Covid? C’è una responsabilità degli adulti? Tra gli esperti più titolati a rispondere c’è Daniela Chieffo, responsabile dell’unità operativa di Psicologia clinica del Policlinico Gemelli di Roma e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervistata per BenEssere da Agnese Pellegrini. Nel 2023, soltanto nel settore infantile e adolescenziale, le prestazioni offerte dal suo team in ospedale sono state ben 12mila.
Professoressa Chieffo, che succede agli studenti italiani?
«Comincerei con un’altra domanda: che sta succedendo ai genitori italiani? Sempre più spesso madri e padri ritengono di essere bravi nel proprio ruolo soltanto se i loro figli hanno ottimi voti in pagella. In questo modo li rendono allo stesso tempo competitivi in modo esagerato e insicuri. E la scuola, che dovrebbe essere un luogo di crescita umana, non solo di apprendimento, diventa per i ragazzi un motivo di stress. Con conseguenze che possono anche essere gravi».
Dipende dai genitori se i ragazzi di oggi sono più fragili a scuola?
«Solo in alcuni casi, non voglio colpevolizzare l’intera categoria dei genitori, ci mancherebbe. I ragazzi si portano dietro un’eredità pesante: il Covid, con la didattica a distanza, ha creato un baratro e non ne siamo ancora usciti. Ce ne accorgiamo con l’aumento di richieste di aiuto inerenti ai disturbi di apprendimento. Ma in generale dovremmo anche ripensare l’intero sistema scolastico».
Essere giudicati con un voto è un problema? Meglio il giudizio?
«Il numero è più chiaro, senza dubbio, e si fa ricordare. Il giudizio, però, serve a non identificare una persona in un voto, ma a interpretarla, prendendo in esame diversi fattori. Andrebbero usati entrambi, per una valutazione globale».
La bocciatura secondo lei è necessaria?
«La bocciatura è educativa in rapporto agli altri compagni: se un ragazzo non studia, ha atteggiamenti di sfida e indifferenza, allora non è giusto che venga promosso come chi invece si impegna sui banchi. Invece, per gli studenti che fanno fatica a essere al passo con il resto della classe, ripetere l’anno non serve: ci sono altre strade per aiutarli a raggiungere la sufficienza. Ecco, tutti i presidi e i professori dovrebbero esserne consapevoli, come dovrebbero cercare di essere vicini ai ragazzi e mai “contro”, per esempio sottoponendoli a verifiche e interrogazioni “punitive”».
La scuola dovrebbe essere una palestra di umanità…
«La scuola ha un ruolo importantissimo, che è quello di sviluppare le abilità sociali, le competenze relazionali come le chiamiamo noi psicologi. Ci riesce nel momento in cui i professori sono sensibili, aperti ed empatici. I bravi insegnanti sono questi».
I compiti a casa sono una delle maggiori fonti di stress, secondo il sondaggio recente di Unisona Live e Unicef: lei li abolirebbe?
«Sì. Andrebbero ridotti moltissimo se non aboliti, perché i ragazzi hanno bisogno di altro al di fuori della scuola. I compiti possono servire in alcuni momenti del percorso scolastico, ma sono negativi se diventano fonte di stress e tolgono tempo per attività di socializzazione e per stare all’aperto, cioè le attività che favoriscono lo sviluppo sano e completo del corpo e della mente».
Da qualche anno il registro elettronico permette ai genitori di monitorare in tempo reale i voti, le note, le assenze dei propri figli. Lei che cosa ne pensa?
«Il registro elettronico può aiutare molto la comunicazione tra la scuola e la famiglia, e in questo senso è uno strumento utile, fa capire al ragazzo che esiste un circuito che lo sostiene. Il rischio è che i genitori si facciano prendere la mano e controllino eccessivamente i propri figli: in questo modo, non li educano all’autonomia e alla responsabilità e li privano di un senso del sé».
Bisognerebbe stressare meno i ragazzi?
«Un po’ di ansia è indispensabile nella vita. Essere tesi prima di un’interrogazione è normale, così come lo è per un adulto esserlo in vista di un appuntamento importante di lavoro. Lo stress aiuta a essere reattivi, è come una molla che ci fa arrivare meglio all’obiettivo che ci poniamo. Il problema è quando diventa eccessivo: può dipendere dalle richieste scolastiche, da genitori richiedenti o da una fragilità dei ragazzi dovuta all’età, alla genetica o ai rapporti con gli altri. Chi soffre di ansia da prestazione può essere come paralizzato: tale la paura di non essere all’altezza di quel voto, di quella verifica, di quell’interrogazione da non riuscire a studiare, a presentarsi in aula, imparare. Tutto questo, nel tempo, può compromettere le possibilità di realizzazione della persona e condurre a uno stato depressivo».
Che cosa si può fare per l’ansia da prestazione?
«I genitori che se ne accorgono dovrebbero innanzitutto parlarne con i docenti. I professori possono aiutare i ragazzi con comportamenti di gratificazione, creando scambi di gruppo e lavori didattici in condivisione, favorendo attività extrascolastiche, perché se un ragazzo ansioso si trova in sintonia con i compagni fuori da scuola, di fronte poi a una prova in aula si sentirà sostenuto. Non bisogna temere poi di intraprendere un percorso di psicoterapia, che può essere di grande sollievo e risolutivo. In alcuni casi, non bisogna escludere un supporto farmacologico, dietro prescrizione medica».
Si sentono spesso adulti che commentano: «Qualche 2 o 4 in pagella prima non era un dramma e ora i ragazzi ne fanno una tragedia». Sono più fragili?
«Tutti gli adolescenti non sono strutturati come gli adulti e temono il giudizio degli altri. Oggi si aggiunge una doppia criticità: molti ragazzi da un lato non sanno gestire il rapporto con l’autorità e dall’altro non riescono a esprimere il proprio disagio, le proprie emozioni».
A proposito di autorità: alcuni genitori prendono le parti dei figli anche con modalità poco civili, come apprendiamo dalla cronaca…
«Ci sono padri e madri che attraverso il voto del figlio si sentono gratificati. Per questo se la prendono con i professori se danno un’insufficienza al ragazzo, perché li fanno sentire cattivi genitori. Criticare l’insegnante serve a non farsi domande scomode. Invece, occorre che famiglia e scuola facciano squadra, perché gli adolescenti hanno bisogno di riconoscere l’autorità e la gerarchia. Soltanto così potranno sviluppare giudizio e senso del dovere».
Tra i giovani è in aumento l’autolesionismo e i casi di suicidio sono triplicati dal 2007 al 2018: fra i 10 ai 14 anni sono la seconda causa di morte tra gli adolescenti europei…
«A volte, i ragazzi sentono il bisogno di esprimere la loro sofferenza attraverso il corpo: hanno un problema che vogliono comunicare, ma non riescono a dirlo, e lo manifestano con gesti di autolesionismo. Per questo dovrebbero esserci sempre più campagne di informazione, per spiegare che non bisogna avere paura di dimostrare il disagio. Chi è fragile non è inferiore agli altri, non è inadeguato: è semplicemente un giovane che, in quel momento della propria crescita, va aiutato. E noi adulti dobbiamo esserci, il compito di tutti noi è quello di renderli responsabili e consapevoli. I ragazzi di oggi hanno bisogno di maturare la loro autenticità, di avere un ruolo, e a volte i comportamenti di autolesionismo o aggressione (penso al bullismo) sono l’unica modalità di esserci e di sentirsi».
Si fa largo sempre di più la convinzione che l’essere perennemente connessi a internet renda più soli. In Inghilterra hanno vietato l’uso dei cellulari a scuola: può essere una soluzione?
«Il rapporto digitale con gli altri anestetizza il corpo, fondamentale invece per la crescita. In questo modo, la solitudine è sempre maggiore e aumentano purtroppo i disturbi fisici e mentali. Ovviamente, non portare il cellulare in classe è educativo perché favorisce la concentrazione e l’apertura verso i compagni».