PHOTO
Un italiano su due è geneticamente intollerante al lattosio, e spesso non sa neppure di esserlo. Geneticamente intollerante significa che non ha ereditato una mutazione genetica che, nel corso di circa dodicimila anni, cioè dall’avvento della pastorizia, ha portato a mantenere un enzima, la lattasi, necessario per digerire il lattosio, uno zucchero contenuto nel latte. Non solo quello di mucca, in tutti i tipi di latte.
Solo una minoranza di persone con questa caratteristica nel proprio Dna, però, manifesta disturbi quando beve una tazza di latte, motivo per cui la percentuale di intolleranti al lattosio accertati è molto più bassa del 50% della popolazione italiana, ma comunque quella al lattosio resta la reazione avversa agli alimenti più diffusa.
I sintomi dipendono dalla dose
Gonfiore, meteorismo, dolori intestinali e diarrea sono i sintomi tipici dell’intolleranza sintomatica e si accentuano con l’aumentare della dose. L’intollerante al lattosio quasi mai ha problemi a bere un caffè macchiato, con il cappuccino già qualche disturbo potrebbe avvertirlo, con la tazza piena di latte i sintomi sono molto probabili, se non certi.
I problemi intestinali si verificano a causa di un fenomeno chiamato malassorbimento. Si ha malassobimento quando il lattosio non viene digerito nel tenue, il primo tratto dell’intestino, a causa di un deficit di lattasi, e raggiunge così il colon, dove viene fermentato dai batteri che compongono il microbiota intestinale. La fermentazione dà luogo a vari gas, tra cui l’idrogeno, e richiama acqua per osmosi. Gas e acqua, se in quantità eccessive, possono causare gonfiori e dolori. Inoltre, il richiamo eccessivo di acqua può provocare diarrea.
Controllare farmaci e integratori
Il lattosio si trova principalmente nel latte e nei suoi derivati, in quantità variabili. È contenuto poi in tutte le preparazioni che hanno il latte tra gli ingredienti, come certe salse e sughi, snack, hamburger, dolciumi e gelati. Solo le persone che hanno una forma accentuata di intolleranza devono fare attenzione anche ad alcuni integratori alimentari e farmaci che possono contenere tracce di lattosio (che però è sempre indicato nelle etichette).
Il test del respiro per una diagnosi certa
L’unico esame scientificamente validato per diagnosticare l’intolleranza al lattosio è il test del respiro, o breath test. È un esame semplice e indolore, solo un po’ lungo da eseguire perché può richiedere alcune ore. Consiste nel far espirare il paziente in un macchinario prima e dopo l’assunzione di una certa quantità di lattosio, a intervalli di tempo regolari.
Il macchinario in cui si soffia misura la presenza di idrogeno nell’aria espirata. Questo gas si forma per le fermentazioni nell’intestino, da lì passa al sangue e quindi ai polmoni, che lo liberano attraverso l’espirazione. La presenza di idrogeno nel breath test è perciò indice indiretto di un’aumentata fermentazione intestinale del lattosio, che non è stato digerito e assimilato.
Impostare la dieta
L’unica soluzione efficace per contrastare l’intolleranza consiste semplicemente nel limitare – neanche eliminare nella maggioranza dei casi – il lattosio. Quanto limitarlo sta a ciascuno capirlo, facendo prove progressive.
Molte persone, per esempio, non hanno alcun problema con i formaggi stagionati oltre i sei mesi, mentre per quelli con stagionatura oltre i 18 mesi possono stare tranquilli anche gli intolleranti più sensibili, perché sono privi di lattosio. Attenzione al latte di pecora e di capra, che ha quasi la stessa quantità di lattosio del vaccino.
I prodotti delattosati? Occhio all’indice glicemico
Sugli scaffali dei supermercati si trovano facilmente i latticini privi di lattosio, detti delattosati. Questi prodotti contengono in genere dieci volte meno lattosio rispetto a quelli “normali”, quota che può andar bene per la maggior parte degli intolleranti.
Va però tenuto presente che latte e formaggi senza lattosio hanno indici glicemici molto più alti dei corrispondenti con lattosio, e per questo non sono prodotti particolarmente salutari. Meglio allora ridurre il carico di lattosio in altro modo, magari sostituendo il latte della colazione con una bevanda vegetale alla soia e con yogurt e kefir, prodotti in cui il lattosio è stato in larga misura fermentato dai lattobacilli.
Quando usare i supplementi
In commercio si trovano integratori a base di lattasi, l’enzima in grado di digerire il lattosio. Non si sa quanto siano realmente attivi ed efficaci questi enzimi assunti e non prodotti dal nostro organismo. È consigliabile non utilizzarli abitualmente e nemmeno nei momenti delicati che potrebbero essere rovinati da una corsa al bagno, come il giorno delle nozze o quello di un importate colloquio di lavoro. È molto più sicuro evitare il lattosio.
Il contenuto di lattosio nei latticini
Il contenuto di lattosio per 100 grammi di parte edibile.
Tra parentesi il contenuto di lattosio per porzione tipica (in grammi).
- Gelato (panna/crema): 6,4 (19,2)
- Latte scremato: 4,8 (14,4)
- Latte intero: 4,7 (14,1)
- Latte di pecora: 4,5 (13,5)
- Cioccolato al latte: 4,3 (1,5)
- Latte di capra: 4,2 (12,6)
- Panna: 3,5 (3,5)
- Panna acida: 3,5 (3,2)
- Yogurt: 3,0 (3,75)
- Burro: 0,5 (0,1)
- Formaggi teneri: 0,5 (1,0)
- Formaggi stagionati (>12 mesi): 0,1 (<0,1)
- Latte delattosato: <0,5 (<1,5)
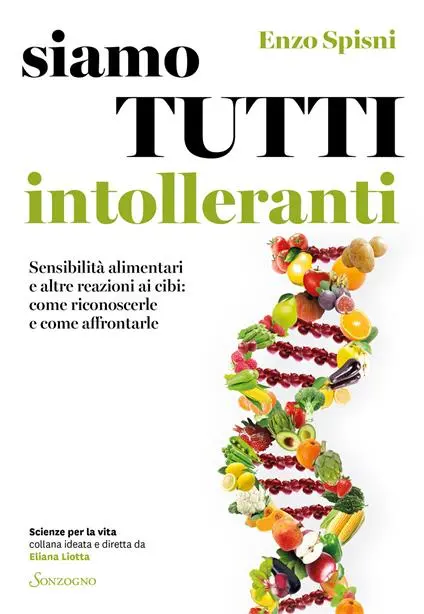
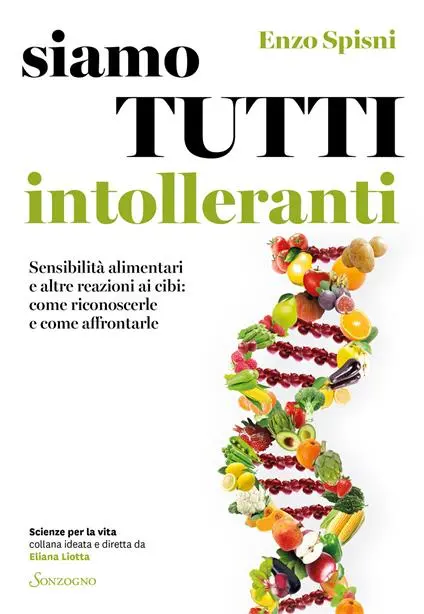
Il testo è tratto dal libro di Enzo Spisni Siamo tutti intolleranti (Sonzogno)













